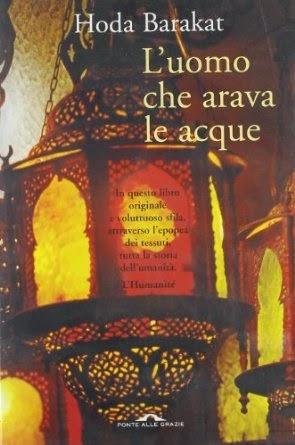Non solo 8 marzo
di Ivana Trevisani (che ringraziamo molto)
Dedicato a Loubna Lafkiri, vittima della metro di Bruxell.
Insegnante per anni di ginnastica e nuoto nella scuola del
quartiere e madre di tre figli. Apprezzata dai bambini e
modello di libertà femminile per le donne della comunità .
Per incontrare la grandezza delle donne non è inderogabile fermarsi all’otto marzo, gli incontri possono accadere prima o dopo la data istituzionalizzata, a Milano sono stati possibili in tre date distinte, in tre luoghi diversi, il 26 gennaio alla Casa dei Diritti, il 5 febbraio alla Casa della Cultura e il 12 marzo a Palazzo Reale.
In una sala della Casa dei Diritti inspiegabilmente, desolantemente vuota, il 26 gennaio la poeta curda Bejan Matur con il suo libro “Guardare dietro la montagna” ci ha aiutate a guardare oltre l’ovvio e spesso il falso della scarna informazione in merito alla questione curda.
L’intento di Matur, come da lei stessa affermato è stato infatti quello di scrivere un libro “rivolto alla comprensione per l’attualità” un tentativo volto a far comprendere “cosa sia successo a proposito della questione curda che continua a crescere d’importanza in Medioriente”. Una necessità, ancor più che un intento , dettata da un sistema mediatico in cui, come sempre troppo spesso dobbiamo constatare come affermato da Matur“ Coloro che si avvicinano alla questione, si fermano a un livello di conoscenza del problema reale, insufficiente”. “Rompendo con i grandi modelli politici, mettendo da parte i luoghi comuni, ho lasciato il lettore testa a testa con il racconto nudo di coloro che erano partiti in montagna, per avvicinare l’opinione pubblica al mondo interiore delle persone etichettate come <terroristi>.”
Matur ha ribadito che “i curdi non sono stati contenti della fusione alla <turchicità>, di scomparire cioè sotto un’altra identità, covando la rabbia che sta dietro l’idea di partire per le montagne armi in mano.” Ancora non un teorico enunciato, ma una constatazione fondata sull’esperienza da lei stessa dolorosamente vissuta che ci ha testimoniato “Quando ero alle elementari ci era vietato parlare curdo anche in famiglia, dentro le proprie case e a turno nominavano degli alunni che avrebbero dovuto girare per il villaggio la sera e ascoltare i discorsi provenienti dalle case, con il dovere di denunciare poi a scuola quelle famiglie che avevano sentito parlare in curdo” Non c’èstato bisogno di enucleare ulteriormente la frustrazione instillata in bambini diventati poi adolescenti e adulti sempre più segnati dalla frustrazione di una violenta e reiterata negazione del sé profondo, del senso proprio di dignità. L’autrice ha preferito riaffermare il proprio impegno ideale” Ho sempre trovato dignitoso restare a fianco di questa lotta per affermare la propria identità, per cercare di comprenderla. Senza poggiarmi su alcuna ideologia, ho voluto parlare soltanto delle persone e delle loro storie. Ho provato a osservare tutte le persone con le quali ho parlato, indipendentemente dal loro credo, senza commentare se fosse giusto o sbagliato, cercando soltando di comprendere, e pensando ascoltandole alla celebre affermazione di Kirkegaard ‘Capire è perdonare‘”.
E riprendendo sempre la latitanza o distorsione della reale condizione curda da parte dei media. Matur ha riaffermato “Una realtà quando è raccontata in quanto realtà raggiunge tutti. E se non bastasse a costruire un quadro della verità, serve però a costituire una chiave importante per leggere l’anima delle persone e della realtà e forse riuscire a comprenderle un poco” ed ha voluto anche sottolineare che una maggiore e migliore conoscenza della gente curda, delle persone una ad una nella loro singolarità, consentirebbe di capire che la forza che è in loro “è nata dallo sguardo della coscienza e della comprensione, non da quello della paura, degli stereotipi e delle frasi fatte.
Credo che questo libro possa essere interessante anche per il lettore italiano.”
Peccato fossimo solo un esiguo numero ad ascoltarla, arrivate e arrivati grazie al passaparola in amicizia: nessuna comunicazione alla mailing list dalla Casa dei Diritti e nessun rappresentante della medesima presente.
Decisamente più popolata il 5 febbraio la Casa della Cultura per l’incontro con Hoda Barakat. La scrittrice libanese, da trent’anni residente a Parigi è stata la voce che ci ha restituito il suo senso dello scrivere nei tempi di grande scompiglio dell’inquieto scenario mediorientale e proposto la sua lettura delle metastasi e delle lacerazioni in atto, in Medio Oriente e in Europa. Ha dedicato un particolare approfondimento alla realtà francese che da trent’anni vive su di sé e sul figlio adolescente, nato in Francia, ma che per la società francese resta arabo. Perchè i ragazzi di oggi, se figli di immigrati, non importa di quale gradino generazionale, vivono ancora da stranieri tra stranieri, a scuola, nei parchi, nei luoghi di ritrovo e di lavoro sono sempre l’altro, scomodo e ripetutamente vessato dalle forze di polizia, come spesso accaduto al suo stesso figlio. Unica colpa: essere portatore di tratti evidenti di arabità “Chi ha tratti arabi è regolarmente fermato e vessato da qualche poliziotto e ne so qualcosa perchè mio figlio ha tratti arabi e molto spesso torna a casa infuriato e frustrato per un’aggressione poliziesca subita“.
Singolare e interessante anche l’analisi, la sua lettura originale della questione emarginazione, Barakat ha rimarcato come l’appartenenza all’identità francese sia stata da sempre negata agli Algerini dalla stessa società francese. Non potendo continuare a definirli arabi, dopo averli sollecitati alla cosiddetta integrazione, ma non accettando al contempo di riconoscerne l’identità di Francesi, la società francese ha coniato una nuova etichetta selettiva di esclusione, ha iniziato ad appellarli ostilmente “musulmani”, contestualmente isolandoli sempre più nei quartieri-enclave di una crescente esclusione.
Gli stessi quartieri quasi esclusivamente abitati dagli immigrati algerini all’epoca del boom migratorio, quando servivano braccia e in Algeria c’era disoccupazione e nessuna prospettiva per il futuro, presto sistematicamente trasformati uno ad uno in ghetto. Quando se ne erano andati dal loro Paese si erano lasciati alle spalle decenni di soprusi e prevaricazione, speravano per i loro figli un futuro sereno di concordia e forse una possibilità di riscatto, per essere ripagati dell’espropriazione coloniale subita, si sono viceversa ritrovati reclusi in circoscritte realtà urbane “a parte”.
Strettamente e inevitabilmente connessa alla problematica dell’emarginazione, la questione dei cosiddetti arruolamenti a Daesh, di cui con grande acutezza e conoscenza vissuta Barakat ci ha offerto una personale analisi, nella sua disamina sostiene che ai giovani immigrati schiacciati dalla negazione di identità, non interessa ormai più comprendere o ascoltare, ma terrorizzare, sono in fuga dalla debolezza che vivono in Francia verso la forza di Daesh. Poichè o c’è giustizia o c’è forza, non si può restare nella debolezza indefinitivamente e, scambiandola per forza, si passa alla violenza. Sospesi in un limbo senza identità e senza futuro, non sanno come riprendere le loro vite, e in questo sta la molla che li spinge verso la criminilità, non sono riusciti a sviluppare un senso di appartenenza abbastanza forte da poter resistere al canto delle sirene di Daesh. Non hanno nulla da perdere e facilmente possono cedere alle promesse accattivanti che incontrano e che operano scientemente per attirarli.
Daesh inoltre offre ai giovani di un’intera generazione convinta di non aver nulla da spartire con i Francesi, condannati a sentirsi cittadini di serie B, l’accoglienza comunitaria che la società francese non consente loro di vivere, poiché non possono esistere come individui, si sciolgono nel gruppo per esistere in dignità, arruolarsi li fa sentire parte di un progetto di lotta per valori comuni.
“Gli ideologi dell’organizzazione hanno utilizzato strumentalmente l’Islam proprio perchè avevano intuito che sarebbe stato un’ottima leva per sollevare le giovani generazioni. Ma non è questione di religione, è l’esclusione sociale che se li porta via!”, essi di fatto convertono la morte sociale in morte eroica.
Successivamente Barakat, introducendo la definizione di metastasi, ha precisato che“quello mediorientale è un mondo devastato dalle metastasi” e purtroppo quasi quotidianamente, possiamo aggiungere, in qualche angolo del mondo anche non mediorientale, una metastasi si manifesta.
In chiusura la lapidaria quanto acuta conclusione di Barakat è stata “siamo lacerati perchè non pensiamo, ma reagiamo”
Il 12 marzo in un salone di Palazzo Reale, un imponente numero di presenze ha accolto Aicha Ech Channa, donna marocchina difficile da definire in una sola parola, se non con un semplice, efficace “grande”! E la grandezza di Aicha Ech Channa è davvero indiscutibile, non solo per gli innumerevoli premi ed encomi internazionali ottenuti e il lavoro sociale che da oltre cinquant’anni svolge quotidianamente nel suo Paese, ma anche per il senso profondo, consapevole e radicato del suo stare nel mondo da donna con altre donne. L’intensità del suo agire e del suo pensiero l’ha riversata come un caloroso fiume in piena, su un pubblico divertito dalla sua implacabile ironia e commosso dalla sua trabordante umanità.
Ech Channa, volendo dichiaratamente restare ai margini di dotte dissertazioni, ha affidato a racconti di vita il dar conto e spiegazione del suo lavoro, i racconti delle ragazze e donne che ha incrociato e aiutato nel corso degli anni con la sua associazione “Solidarité féminine”.
“In Marocco, nonostante il nuovo codice di famiglia, la mentalità è ancora ancorata a vecchi schemi che penalizzano le donne” ha chiarito l’infermiera e assistente sociale Channa. Anche se insufficiente e riduttivo dire di lei infermiera e assistente sociale, Aicha Ech Channa è anche questo, e in questo si radica il percorso poi realizzato con l’associazione da lei fondata e presieduta trent’anni fa, che si prende cura di donne e ragazze madri a seguito di abusi, violenze e abbandono, dai 15 ai 40 anni. Spezzando un tabù antico e resistente al cambiamento Aicha Ech Channa, come ci ha ricordato con commovente nota autobiografica, ha voluto creare l’associazione per poter migliorare la condizione delle ragazze madri e dei loro bambini, perchè non fossero più costrette ad abbandonarli. Nella sua associazione infatti, le madri rifutate dalle loro famiglie
oltre all’ospitalità, ricevono il sostegno necessario per reinserirsi nella società che si concretizza nello studio e nella formazione professionale oltre che nella ricerca di opportunità di lavoro, per poter assicurare, attraverso l’indipendenza finanziaria e il lavoro, prospettive concrete di autonomia.
“La migliore soddisfazione possibile per me, è vedere una donna arrivata da noi in stato di choc, senza risorse e speranze, rialzare la testa e riappropriarsi della propria vita, lavorare e crescere i figli”, ha affermato Channa, richiamando spesso nella sua esposizione al valore e alla forza personale e sociale della stima di sé. E proprio attraverso l’agire sociale che persegue con la sua associazione, Aicha Ech Channa incoraggia un cambiamento di mentalità e comportamenti non solo nelle donne ma nell’intera società marocchina.
Identità sospese, interrotte, incerte, identità negate, maldestri e pericolosi tentativi di recupero d’identità é stato il filo che ha attraversato tutti i tre incontri/racconti, ma non un’identità teorica, astrattamente cattedratica, ma identità intesa e trasmessa e sottolineate dalle tre donne in quanto libero senso di sé e del proprio stare nel mondo.
Tre donne geograficamente più o meno lontane dall’Italia e tra i loro stessi Paesi, ma che hanno ugualmente espresso, nelle parole e nell’agire in libertà femminile il rifiuto a restare nel pre-giudizio, nel luogo comune e a privilegiare, fino a renderla ineludibile e fondamentale una pratica di relazione che consente di arrivare al cuore della persona e della realtà e poterla comprendere.
Un avvicinamento al vero che può aiutare a comprendere che cosa è successo e cosa sta succedendo, a tentare di pre-vedere e prevenire ciò che potrebbe ancora accadere ha accomunato queste tre donne non comuni.
Un impegno il loro difficile, “contromano”, eppure mediaticamente analogamente
che è possibile accostare alla lotta di altre donne in una Bruxell ricordata ora solo per i tragici recenti attentati. Ma la città dove le madri “orfane di figli” dell’Associazione “Ls parents Concernés” attraverso l’attività costante e certamente non facile nelle scuole, nelle case, nei luoghi di ritrovo dei disorientati e disorientanti quartieri a rischio di Molenbeek, Schaerbeek e Vilvoorde, tentano un lavoro di ancoraggio identitrio libero dai dati anagrafici e più fondato sulla peculiarità dei dati personali e sul riconoscimento della singolarità e dei suoi valori. Donne impegnate a sostituire la repressione con la cultura come arma autenticamente efficace a contrastare tragiche derive che si prendono i propri e gli altrui figli.
Tre incontri, tre donne che sono state appunto eco di molte altre che mostrano come il guardare oltre le date obbligate e oltre l’angusto limite dei propri confini geografici, culturali e umani possa darci un guadagno di nuova ricchezza interiore e di pensiero personale che può farsi collettivo.