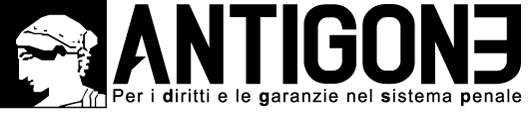Contro i due decreti del Governo in materia di Immigrazione e Sicurezza
ANTIGONE & CILD
I nostri argomenti costituzionali, giuridici, sociali e culturali contro i due decreti del Governo in materia di Immigrazione e Sicurezza
DECRETI SICUREZZA E IMMIGRAZIONE: MANCANO I REQUISITI DI NECESSITA’ E URGENZA
In questi giorni papa Francesco ha ribadito che i quattri verbi che dovrebbero essere posti al centro del grande tema delle ‘migrazioni’ sono: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Invece i due decreti del Governo rispondono a un’altra sequenza verbale: imprigionare, espellere, escludere.
I due decreti del Governo su sicurezza e immigrazione rispondono alla medesima logica politica di carattere non progressista e liberale, una logica di tipo vessatorio, a tratti classista. Da un lato la criminalizzazione dell’accattonaggio, dall’altro il rafforzamento del sistema reclusorio sono entrambi funzionali a quella che potremmo definire una politica di segregazione ed esclusione sociale.
I numeri non in crescita dei migranti irregolari, i numeri degli sbarchi, i numeri dei reati di strada non giustificano dal punto di vista costituzionale l’uso della decretazione di urgenza. Non si vede perché ad esempio la negazione del diritto all’appello per i richiedenti asilo o i maggiori poteri ai sindaci debbano avvenire senza dibattito parlamentare vero e con decreto-legge.
Di altro ci sarebbe urgente e necessario bisogno: di tutele sociali, di accesso alla giustizia, di criminalizzare la tortura, di regolarizzazioni su larga scala di migranti.
DECRETO SICUREZZA
UN PASSO INDIETRO CHE INSEGUE LOGICHE ILLIBERALI E SECURITARIE
Il decreto sicurezza si pone in sorprendente continuità col decreto-legge del 5 maggio del 2008 (cd decreto Maroni), di cui rilancia lo spirito, proponendo un’idea di una sicurezza che considera la marginalità sociale presente nello spazio pubblico come elemento deturpatore del “decoro”, della “quiete pubblica” e finanche della “moralità” (citazioni del decreto).
E’ questa un’idea vecchia e banalmente repressiva di sicurezza. Esiste invece una tradizione di sicurezza ‘democratica’, partecipata, ispirata a logiche di prevenzione che non trova spazio nei decreto del Governo Gentiloni.
Il decreto Minniti è dunque una risposta securitaria a un problema sociale: ai soggetti vulnerabili che popolano lo spazio urbano (clochard, venditori ambulanti, prostitute etc.) si oppone un armamentario di sanzioni, principalmente amministrative. Alcune di queste sono nuove, altre costituiscono un rafforzamento di vecchie norme.
La parola-chiave più ricorrente nel testo è “sicurezza integrata”. Si promuove un’architettura istituzionale che includa i vari attori pubblici (statali, regionali, comunali) facendoli agire in maniera sinergica. Il problema è l’obiettivo verso cui tende questa concentrazione di energie. Nella pratica, a partire dal modello della grande agglomerazione urbana, si introduce la figura di un sindaco dotato di più ampi poteri, le cui ordinanze incidono in maniera significativa sulla libertà di circolazione.
Il potere d’azione dei sindaci è rafforzato mediante modifica dell’art. 50 del Testo Unico sugli Enti Locali (già modificato dal decreto Maroni e su cui intervenne la Corte Costituzionale, dichiarando la norma modificata incostituzionale). E’ allargato il campo di intervento dei sindaci, le cui ordinanze si applicano ad ambiti più ampi (sia ordinarie che straordinarie).
Come già avvenne col decreto sicurezza Maroni, si abbatte una scure sanzionatoria su clochard, venditori ambulanti di prodotti contraffatti, elemosinanti, prostitute, consumatori di droghe, profili sociali tanto variegati quanto accomunati dalla mancanza di risorse che li contraddistingue. Si identificano degli indesiderabili da sanzionare e espellere da alcune aree dello spazio pubblico.
Poiché buona parte delle figure sociali enumerate si trovano spesso ad essere anche stranieri non residenti nell’UE, alle difficoltà sociali si affianca e intreccia uno status giuridico traballante, reso ancor più fragile dal secondo decreto che vede nel Ministro Minniti il proponente.
Si propone dunque l’ennesimo decreto-sicurezza nonostante il numero dei reati di strada non sia in aumento e nonostante vi sarebbe bisogno di ben altro impegno dei sindaci nel tradizionale lavoro di sostegno sociale alle marginalità persistenti nel territorio urbano.
IN CONTINUITÀ’ CON IL DECRETO MARONI E L’INCOSTITUZIONALITÀ’ DELLO STESSO
Come già detto, il decreto Minniti asseconda una svolta normativa prodotta con il decreto Maroni, entrato in vigore nel 2008. Ci fu molta propaganda intorno ai poteri di sindaci che si affrettarono a definirsi sceriffi.
Si moltiplicarono ordinanze creative e ridicole sulla sicurezza (divieti di sedersi in panchine pubbliche, di riunirsi o mangiare gelati in piazze pubbliche, di mendicare in centri storici).
In quel caso alcune norme furono dichiarate incostituzionali in seguito al caso sollevato contro il comune di Selvazzano, riguardante un’ordinanza che proibiva l’accattonaggio. Le ragioni dell’incostituzionalità furono diverse. Una è la dotazione di poteri non sufficientemente delimitati ai sindaci.
Questa la norma dichiarata illegittima dalla Consulta con sentenza 115 del 2011:
«il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana».
Oggi la norma viene riproposta, seppur con qualche differenza.
Secondo la Corte l’ordinanza violava l’articolo 23 della Costituzione («Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»), l’articolo 3 («Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». E questo lo viola anche adesso) e l’articolo 97 primo comma («I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione»). La legge era discriminatoria nei confronti delle minoranze etniche nel consentire ordinanze come quella anti-mendicanti.
Il decreto Minniti in perfetta continuità con il decreto Maroni vuole punire i poveri.
LE ALTRE NOVITÀ’ PERICOLOSE DEL DECRETO MINNITI
Il ministro dice che non ci sono nuovi reati ma solo illeciti amministrativi. In ogni caso un’autorità non giurisdizionale può vietare o limitare la libertà di circolazione con atto amministrativo.
Con modifica dell’art. 50 del TUEL, in caso di situazioni contingibili e urgenti, il potere di ordinanza non riguarda più unicamente l’ambito sanitario. Ora ci sono il decoro, l’accattonaggio, la prostituzione, la vendita di materiale contraffatto.
E’ la palese criminalizzazione dei migranti e dei poveri. Si prevedono multe a delle persone che non potranno pagarle.
Ci sono poi delle palesi illegittimità costituzionali che al pari del potere dei Sindaci già censurato dalla Corte Costituzionale dovrebbero essere sollevati in sede pregiudiziale. Il decreto prevede che il sindaco prima e il questore poi (conferma dopo 48 ore) può per talune persone disporre l’allontanamento e il divieto di accesso a certi luoghi per periodi non superiori all’anno. Le norme violate sono di questo tipo: “condotte lesive del decoro urbano, violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi (anche in conseguenza di assunzione di sostanza alcoliche o stupefacenti), prostituzione con modalità ostentate”. Vengono pure sequestrati gli oggetti con cui si pongono in essere queste condotte.
Ora, le sanzioni raddoppiano nel caso in cui le persone colpite dalla sanzione siano state condannate con sentenza confermata in appello per reati contro la persona o il patrimonio. Ciò vuol dire che 1) si violano il principio di uguaglianza e il principio di presunzione d’innocenza (la persona potrebbe essere assolta in Cassazione); 2) che potrebbe verificarsi una persona si veda comminata una sanzione pecuniaria e l’allontanamento da una parte della città a causa di una condanna che poi non viene confermata.
Nell’articolo 10 si specifica che la concessione della libertà condizionata può essere revocata qualora e laddove questi divieti non vengano rispettati. Per cui vi è anche un riflesso in materia penale e penitenziaria.
Infine il decreti prevede che alle persone condannate, anche con sentenza non definitiva per vendita o cessione di sostanze stupefacenti il questore, sempre lui, possa disporre il divieto di accesso e stazionamento in certi luoghi (tipo locali) per un periodo non inferiore a un anno e di massimo cinque anni. Norma vessatoria, illegittima, violativa degli articoli 3 e 27 della Carta Costituzionale. Si viola chiaramente il principio della presunzione d’innocenza. E poi: il periodo minimo pare un’enormità. Poi magari è già così, ma resta il fatto che sia, credo, un’enormità. E poi il questore può disporre obblighi di firma in commissariato e simili (residenza, orari anticipati etc.). L’allontanamento e il divieto di accesso valgono anche per i minorenni al di sopra dei quattordici anni.
La sanzione amministrativa è abnorme: dai 10.000 ai 40.000 euro, con sospensione della patente dai 6 mesi a 1 anno. Tutto ciò, per persona non ancora condannate in via definitiva. Per cui, ne desumo, una persona potrebbe essere multata con 40.000 euro e però poi assolta in sede penale. E a essere colpiti potrebbero essere giovani, poveri, immigrati.
DECRETO IMMIGRAZIONE
LE POLITICHE MIOPI DEL GOVERNO SU IMMIGRAZIONE E ASILO
Invece di affrontare con lungimiranza ed umanità quel fenomeno storico che è l’immigrazione, il governo italiano non riesce ad abbandonare l’ottica emergenziale e si ostina a proporre politiche miopi ed inadeguate. La formula della riduzione di diritti e garanzie è infatti una risposta evidentemente inadeguata per sanare il sistema di accoglienza italiano.
Procediamo per ordine andando a guardare più da vicino i punti fondamentali del piano del governo su immigrazione e asilo e le relative criticità.
Nella visione del Viminale, la prima e più fondamentale esigenza è una ed una soltanto: rimandare a casa quanti più “irregolari” possibili. Stando al testo del decreto, l’obiettivo primario è infatti quello di “garantire l’effettività’ dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dei cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare”. Tanto che a questo fine – i.e., garantire l’esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, “anche in considerazione dell’eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa” – vengono stanziati per il 2017 oltre 19 milioni di euro.
Questo vuol dire accelerare ed aumentare i rimpatri forzati, soprattutto attraverso la firma di accordi bilaterali con i paesi di origine e transito dei migranti – anche se si tratta di dittature sanguinarie come il Sudan di al-Bashir o paesi noti per le sistematiche violazioni dei diritti umani come la Libia. Nell’ambito del processo di esternalizzazione delle proprie frontiere l’Italia non si fa infatti problemi a sedersi al tavolo delle trattative con i peggiori dittatori del mondo (che vengono peraltro così pericolosamente “rivalutati” come legittimi attori della politica internazionale).
Con quali costi e conseguenze?
È bene ricordare in questa sede che l’Italia ha già ricevuto nel 2012 una dura condanna della Corte Europea dei diritti dell’uomo (caso Hirsi) relativamente ai rimpatri forzati verso la Libia di Gheddafi in attuazione dall’accordo tra il dittatore africano e l’allora premier Silvio Berlusconi (adesso replicato da una contestatissima intesa tra il nostro governo e quello libico internazionalmente riconosciuto). Adesso a questa condanna rischia di farne seguito un’altra, essendo stato recentemente presentato a Strasburgo un ricorso contro l’Italia per la violazione del principio di non refoulement e del divieto di espulsioni collettive nel contesto del rimpatrio forzato di 48 sudanesi realizzato ad agosto 2016.
Insomma: l’Italia considera perfettamente accettabile disporre rimpatri ad alta velocità e bassa garanzia, che però secondo il diritto internazionale sono ammissibili solo verso i cosiddetti “paesi terzi sicuri”.
Definizione in cui sicuramente non rientrano né la Libia né il Sudan, e per dire il contrario non basta l’impegno formale dei governi interessati al rispetto dei diritti umani: il dato giuridicamente vincolante per valutare se un paese è sicuro resta la situazione di fatto e non anche le promesse di un dittatore (come appunto ricordato dalla CEDU nel caso Hirsi).
ESTENSIONE DEL SISTEMA DELLA DETENZIONE
Nell’attesa di stipulare e rendere esecutivi altri accordi come quelli già siglati ed ottenere così – ad ogni costo – l’accelerazione delle procedure di rimpatrio, la soluzione principe pare sempre quella della detenzione amministrativa, che cambia nome ma non sostanza. Il secondo elemento della ricetta del governo è infatti quello dell’estensione del sistema della detenzione amministrativa per gli immigrati. Allungamento della durata massima del trattenimento – da 90 a 135 giorni – e quadruplicazione della capienza – dai nemmeno 400 posti attuali a 1600 – tramite l’apertura di nuovi centri, che, nella visione del Ministro, con gli attuali Centri di identificazione e espulsione (Cie) non dovrebbero avere proprio niente a che fare.
Nuovi nomi – da Cie a Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) – e nuovi centri – uno in ogni regione, che però non cambiano la sostanza. In questo modo si continua infatti a ignorare il fallimento storico del sistema della detenzione amministrativa, che è innanzitutto disumano – le condizioni nei centri sono tanto disperate che alcuni casi di rivolta violenta sono stati ritenuti dai giudici legittima difesa dei trattenuti contro la privazione dei propri diritti fondamentali – ma anche inutile – la maggior parte delle persone che transita nei Cie non viene poi effettivamente rimpatriata – e incredibilmente costoso.
ASILO SENZA APPELLO E SENZA GARANZIE
La situazione cambia in peggio non solo per i cosiddetti “irregolari” ma anche per i richiedenti protezione internazionale. Per intervenire sul sovraccarico del sistema di asilo ed accoglienza e ridurre i tempi eccessivamente lunghi delle procedure, il governo propone infatti una soluzione molto semplice: ridurre le garanzie in sede giurisdizionale.
L’eliminazione del grado di appello per chi ha ricevuto un diniego dell’asilo in primo grado, sacrifica in maniera evidente i diritti delle persone vulnerabili di fronte all’esigenza di alleggerire il carico dei Tribunali e dei centri di accoglienza.
Il diritto all’asilo attiene al diritto alla vita. Non si possono comprimere le garanzie giurisdizionali.
All’eliminazione del grado di appello si aggiungerebbe poi la sostituzione del rito sommario di cognizione con quello camerale e, soprattutto, l’eliminazione – salvo pochi casi – dell’udienza e quindi della comparizione personale del ricorrente. Questo implicherebbe l’impossibilità per il giudice di primo grado di ascoltare di persona il ricorrente, in violazione con la direttiva europea sulle procedure, secondo la quale il ricorso effettivo comprende l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto e quindi, nel caso di specie, l’ascolto del richiedente la protezione: secondo il diritto europeo il giudice dovrebbe insomma ascoltare il richiedente asilo, fargli delle domande, andare ad ascoltare le fonti – e per assolvere questi obblighi non può certo bastare, come si propone, la visione della videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale. Questo assetto è evidentemente inidoneo a garantire le regole del giusto processo e del principio del contraddittorio sancito dall’art. 111 della nostra Costituzione – in quanto in questo modo si utilizzerebbe una prova formata dall’Amministrazione, senza che al ricorrente sia consentito di eccepire violazioni e la decisione giudiziale verrebbe basata su dichiarazioni rilasciate in fase amministrativa (e non invece su dati e elementi acquisiti dal magistrato al momento della decisione, come vorrebbe la legge).
Infine, solleva perplessità anche l’idea di creare nei tribunali di primo grado delle sezioni specializzate con giudici dedicati a cui non potrà essere assegnata altra mansione che quella di analizzare i giudizi in materia di immigrazione, poiché questa specializzazione potrebbe tradursi in una vera e propria “ghettizzazione processuale” nonché porsi in conflitto con il divieto costituzionale di istituzione di giudici speciali (ai quali, più che una materia, verrebbe assegnata una categoria di persone qualificate solo in base alla nazionalità).
LAVORO NON RETRIBUITO, LAVORO SENZA DIGNITA’
Intanto, per evitare “il vuoto dell’attesa” – così il ministro Minniti definisce, eufemisticamente, il limbo disperante in cui si trovano migliaia di persone abbandonate in condizioni di accoglienza precaria in attesa di ricevere risposta alla propria richiesta o ricorso – si propone la soluzione di “lavori di pubblica utilità, finanziati con fondi europei”. Con l’immediata precisazione che però “non si creerà una duplicazione nei mercati del lavoro, perché non sarà un lavoro retribuito”. Ed allora, visto che le parole contano, sarebbe forse meglio non parlare di lavoro ma bensì di un volontariato. In ogni caso assolutamente inammissibile sarebbe rendere questo lavoro socialmente utile obbligatorio ai fini dell’accoglienza o in qualche modo condizionante il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Il lavoro perde dignità se gratuito.