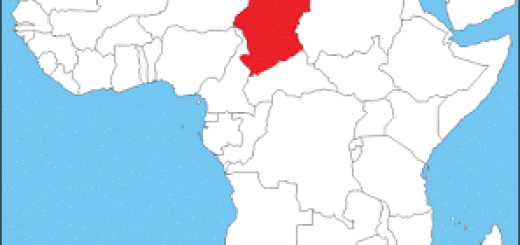Un altro me: il documentario che entra in carcere e racconta la presa di coscienza
Il documentario di Claudio Casazza intitolato “Un altro me” e vincitore del Premio del pubblico al 57mo Festival dei Popoli, è frutto di due anni di lavoro e segue l’evolversi dei colloqui in carcere tra un gruppo di uomini che hanno commesso violenze sessuali e l’unica equipe in Italia che da oltre un decennio porta avanti il primo Trattamento Intensificato per autori di reati sessuali.
Associazione per i Diritti umani ha realizzato l’intervista a Claudio Casazza e lo ringrazia per la sua disponibilità.
Come è stato realizzato questo progetto?
Ho scelto un approccio di osservazione; l’obiettivo era quello di essere presente durante tutto il periodo del percorso, cioè tutto l’anno – da novembre 2014 a ottobre 2015 – per seguire quello che succedeva. I detenuti svolgono le attività cinque giorni alla settimana e io mi recavo tutte le settimane.
Sono entrato in maniera più aperta possibile, senza conoscere fino in fondo quello che sarei andato a riprendere, per avere un territorio libero da esplorare e questo è molto importante in particolare per creare un rapporto di fiducia con chi ha commesso reati molto gravi. Ho scoperto ciò che loro avevano fatto mentre lo raccontavano durante le sedute del percorso.
Quali sono state le scelte di post produzione, dato il luogo così particolare e gli argomenti così delicati?
Ho deciso di riprendere i detenuti tenendoli fuori fuoco per un duplice motivo: per tutela delle vittime in prima istanza e per i detenuti stessi.
In ripresa eravamo sempre in due: io che usavo la macchina da presa e un fonico e, quasi più della telecamera piccola, era molto presente il microfono che risultava un po’ invasivo. Ma dopo un po’ di tempo i detenuti si sono abituati alla nostra presenza che è stata il più discreta possibile, senza interferenze.
Il mio intento non era quello di fare un film sul carcerario, ma volevo raccontare un percorso di presa di coscienza.
Non deve essere facile per gli psicologi e i criminologi assorbire questo genere di racconti…
Da un lato per loro si tratta di lavoro per cui è quasi un’abitudine, da un altro è sicuramente duro quello che fanno, infatti hanno dei momenti di compensazione in cui quasi si divertono perché hanno bisogno di tirar fuori, di esternare tutto il male che immagazzinano per non portarselo dietro.
Il carcere può essere uno strumento di recupero per persone che hanno commesso reati così gravi?
Il carcere dovrebbe essere uno strumento di recupero per evitare il rischio di recidiva che, in generale, è alto.
Il lavoro che fanno nell’istituto di pena di Bollate – e che dovrebbe essere svolto in ogni istituto – è importante anche in relazione alle vittime che sono fuori e sono persone che hanno bisogno di essere sicure che si stia svolgendo un percorso di recupero vero.
Se ci sono, quali sono i segnali di una presa di coscienza da parte dei detenuti e del dolore che hanno inflitto alle vittime e ai loro familiari?
Mi accorgevo che in molte persone c’era un passaggio su alcuni temi, ad esempio su come la relazione era vista. All’inizio la vittima era considerata soltanto un oggetto poi, invece, come individuo. E questo è un primo cambiamento; da qui si comincia a vedere il danno compiuto e, infine, arriva la consapevolezza.
Sono sedute di gruppo e il detenuto compie il percorso soprattutto ascoltando gli altri e identificandosi con le vittime: questo è interessante perché magari, all’inizio, ogni detenuto si sente più vicino al compagno di cella, ma dopo riesce a mettersi nei panni della vittima.