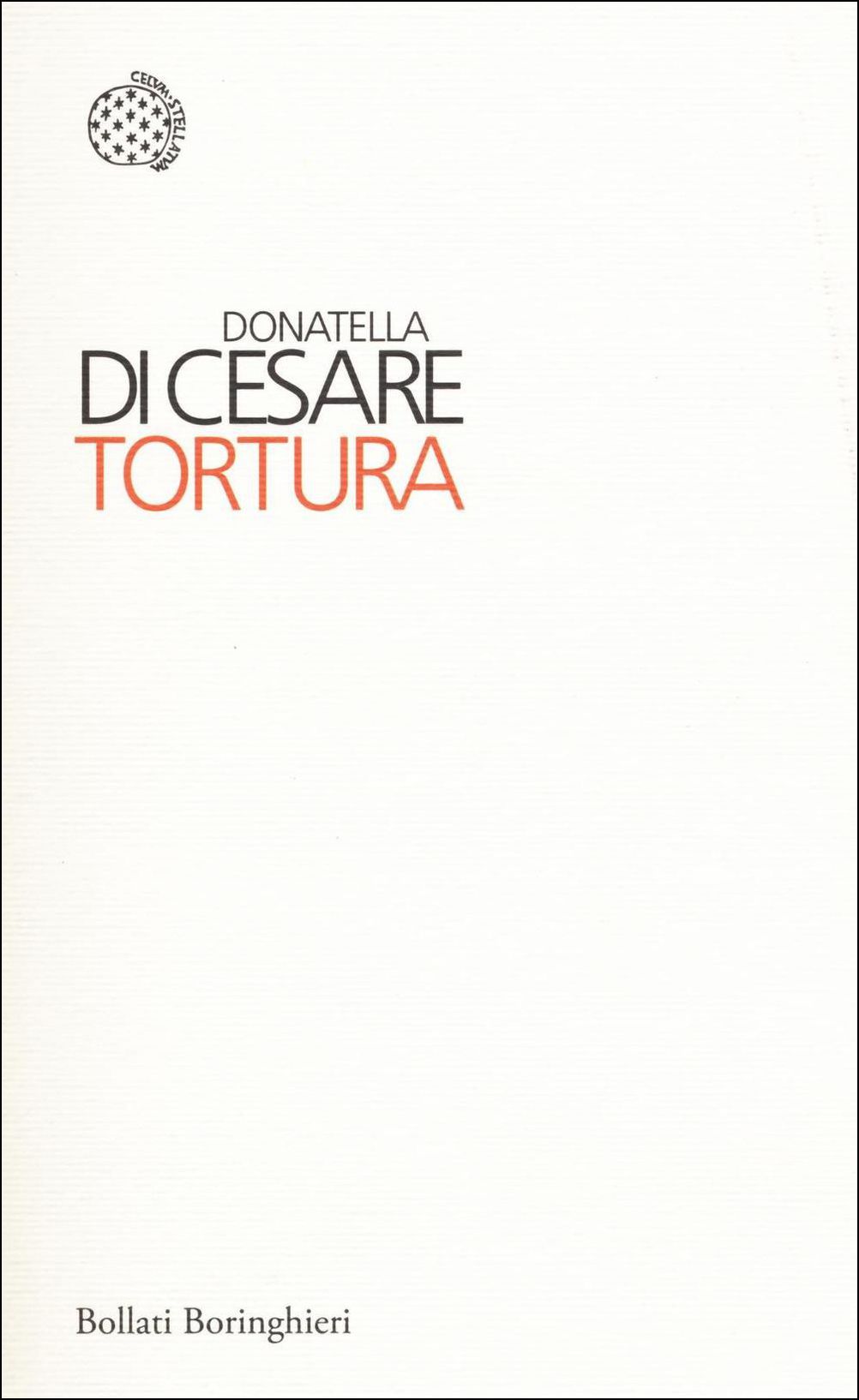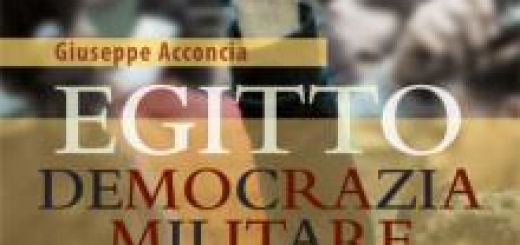TORTURA. Intervista a Donatella Di Cesare
“Se lo stato tortura, non abusa solo del potere, ma incrina anche la fiducia dei propri cittadini che, anziché difesi, vengono inaspettatamente offesi, colpiti nella loro disarmata vulnerabilità. Lo Stato che tocchi il corpo di un cittadino è già illegittimo. Anche se si tratta di un detenuto”.
TORTURA è il titolo del nuovo saggio della filosofa Donatella Di Cesare, edito da Bollati Boringhieri. Associazione per i Diritti umani ha rivolto alcune domande all’autrice e la ringrazia molto per il tempo che ci ha dedicato.
Perché un approccio filosofico al tema della tortura?
Il mio è un libro anzitutto politico, o meglio, filosofico-politico. Anche nel passato mi sono occupata di diverse forme di violenza. Fa parte del mio impegno. Per quel che riguarda la tortura, credo che domini il pregiudizio illuministico che la considera semplicemente una forma di “barbarie” oppure una “follia”. Ma così si liquida la faccenda e ci si lava le mani, senza capire quello che avviene intorno a noi. Spesso infatti si presume di sapere che cosa sia la tortura – e invece non lo si sa. Perciò ho pensato che fosse necessario, anzi indispensabile, contribuire a un dibattito più approfondito. Oggi la tortura assume infatti forme nuove. Negli Stati Uniti c’è chi, anche tra i pensatori liberal, crede ad esempio che di fronte al terrorismo sia lecito ricorrere alla tortura. I «diritti umani», per quello che ancora significano, vengono così scalfiti. La questione riguarda l’etica e la politica.
L’esercizio della tortura appartiene alle dittature oppure anche agli Stati liberi?
La tortura si è democratizzata, è entrata subdolamente all’interno della democrazia. Apparentemente è stato abolita; ma esiste una «tortura dopo l’abolizione della tortura». Perciò io la chiamo la «fenice nera». C’è dunque una democratizzazione della tortura di cui dobbiamo prendere atto. Quasi ovunque la tortura, dichiarata illegale, passa da una parte all’altra della sbarra: da regina della prova viene degradata a oscura e temibile complice del potere. E lo Stato si adegua: mette “fuori legge” la tortura, ma seguita a praticarla, o meglio, a farla praticare sotto banco, in modo più o meno nascosto. Come lottare, allora, contro la tortura, se a delinquere è lo Stato? E se, inoltre, lo Stato nega? Se si rifiuta di ammettere qualsiasi responsabilità, appellandosi alla propria legislazione che la vieta ufficialmente? Soprattutto: se è lo Stato stesso a trasgredire, chi ne accerterà la colpa? Perché è ovvio che, chi ha commesso il reato, si sottrarrà a ogni giudizio. Il problema appare tanto più complesso, in quanto il torturatore, che prima agiva alla luce del sole, si nasconde dileguandosi nei meandri dell’apparato statale. E lo Stato necessariamente lo difende, gli offre riparo. Perché l’aguzzino permette la repressione nel silenzio. Lottare contro la tortura vuol dire cercarne le tracce nell’ombra, sorvegliare gli abusi, denunciare un potere che agisce nella segretezza e che, rischiando costantemente l’illegittimità, non si limita a intimidire, ma reagisce con violenza. Di qui il ruolo determinante svolto dai media e dall’opinione pubblica, insieme alle associazioni come la vostra. Ma sapere non vuol dire sempre potere. E la mole di informazioni accresce persino il senso di impotenza in una lotta il più delle volte impari, dove il reo è quasi sempre lo Stato. Il web ha contribuito al controllo e alla trasparenza. Basti pensare alle schede segrete dei detenuti di Guantanamo rivelate da WikiLeaks. Spesso, però, i rapporti di forza restano immutati.
Come si può rispondere a chi chiede se sia lecito torturare, ad esempio, un attentatore per salvare vite umane?
È impossibile rispondere a questa domanda negli spazi ristretti di una intervista. Devo perciò rinviare al libro dove cerco appunto di mostrare che la storiella del ticking bomb è una storiella che non si è mai verificata, una fiction sulla base della quale si pretenderebbe di legiferare, di produrre leggi e soprattutto di far passare la tortura come un mezzo lecito contro il terrorismo.
Da una punto di vista anche psicanalitico, si può considerare la tortura un uso del potere di un essere umano nei confronti di un altro, una sorta di delirio di onnipotenza?
No, assolutamente no. Anzi credo che termini come «delirio» siano, in questo contesto, pericolosissimi. La tortura non è lo scatto di follia di un singolo. È violenza sistematica, organizzata, metodica; non sfugge, ma resta sotto controllo, e con ferma volontà, con voluttuosa tenacia, torna ad abbattersi sulla vittima. E certo ridurre l’altro alla nuda impotenza dà un senso di illimitato potere. Ma lo scenario della tortura, sebbene ci sia un faccia a faccia tra carnefice e vittima, che io ho cercato di descrivere, è sempre uno scenario che coinvolge altri, che richiede terzi, che implica il potere.
Quali sono le caratteristiche della tortura che la rendono peggiore della stessa morte?
Una volta morto, l’altro diventa un ente che, nella sua inerzia, che non fa più attrito e su cui non può più scatenarsi l’inebriato tripudio dell’aguzzino. Uccidere una donna non è lo stesso che violentarla davanti al marito o farla violentare da fratelli e figli. Per chi è stato vittima, la tortura significa esperire in vita la propria morte. Ce lo ricorda Jean Améry la cui testimonianza è davvero imprescindibile e che perciò nel mio libro svolge un ruolo di primo piano.
Nell’ultimo capitolo del Suo libro lei affronta casi scottanti di attualità, da quello di Giulio Regeni al G8 di Genova, ma anche delle Brigate rosse. E usa il termine «amministrazione» della tortura.
Sì perché la tortura viene semplicemente amministrata, quasi come una pratica burocratica. Ecco perché il riconoscimento del «reato di tortura» in Italia sarebbe un traguardo importante. Ma non è ancora tutto. Perché dopo sarà necessaria più che mai la vigilanza e la riflessione.