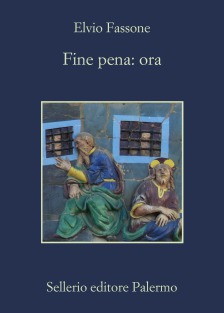Fine pena: ora. Intervista al giudice e senatore Elvio Fassone
Una corrispondenza durata ventisei anni tra un ergastolano e il suo giudice. Non è un romanzo di invenzione, né un saggio sulle carceri, non enuncia teorie, ma si chiede come conciliare la domanda di sicurezza sociale e la detenzione a vita con il dettato costituzionale del valore riabilitativo della pena, senza dimenticare l’attenzione al percorso umano di qualsiasi condannato. Una storia vera, un’opera che scuote e commuove.
Stiamo parlando del romanzo Fine pena: ora del giudice e senatore Elvio Fassone che ringraziamo tantissimo per la disponibilità e gentilezza nel rispondere alle nostre domande.
Il romanzo nasce da una storia vera: ce la può raccontare e può spiegare perchè ha scelto la forma narrativa – e non saggistica – per riflettere sul tema della giustizia riparativa?
La forma narrativa mi è parsa la più appropriata per almeno due ragioni.
La prima è data dal momento in cui è maturata la mia decisione: fu il giorno stesso in cui mi giunse la lettera con la quale Salvatore mi annunciava che la settimana prima aveva tentato il suicidio impiccandosi. Mi venne naturale chiedermi che cosa potessi mai fare per lui, e mi risposi che l’unica cosa concreta era raccontare la sua vicenda e la sua disperazione. Non potevo certamente pensare ad un saggio levigato e filosofico, buono al più per qualche biblioteca o convegno. C’era carne viva in gioco, un secondo gesto tragico era nell’ordine delle cose possibili, forse probabili. Tirai fuori lo scatolone delle lettere e scrissi il libretto in due o tre settimane.
La seconda ragione è che questa storia è diversa da tutti gli altri libri sul carcere. La letteratura penitenziaria è amplissima, e contiene molte pagine belle: alcune – la memorialistica – sono scritte dal protagonista, che è o che è stato in carcere; altre – la saggistica – sono redatte da scrittori, giornalisti, studiosi, che intendono denunciare la realtà carceraria; e tutte si propongono di far sapere all’esterno quanto sia dolorosa e dura la prigione. “Fine pena: ora” è diverso, perché è costituito da materiale che, quando fu creato, non pensava neppure lontanamente di diventare un libro.
Salvatore, quando mi scriveva, non voleva convincere nessuno, nemmeno me. Dalle sue lettere non si aspettava nulla. Non da me, che ormai ero uscito dal processo e quindi dalla sua sorte; e non dall’esterno, perché io ero l’unico destinatario, e lui lo sapeva. Lui non mi chiese mai nulla, se non qualche consiglio, o chiarimento su questioni giuridiche; e nemmeno io gli chiesi mai nulla, meno che meno informazioni sul suo ambiente.
Se avessi scritto un saggio, avrei dato vita all’ennesima doglianza esplicita sul carcere. Non era quello il mio scopo: io avevo tra le mani una miniera straordinaria, dovevo solo darle voce pubblica (beninteso con il permesso di Salvatore, che ottenni non senza qualche fatica). Era una voce genuina, non corrotta da alcuna intenzionalità, da alcun obiettivo. Persino come epistolario questa raccolta è anomala, perché compaiono solo le sue lettere, non le mie, che avrebbero guastato l’atmosfera e il clima. Credo sia per questo che il libretto è stato accolto bene da così tante persone.
Credo sia interessante anche una riflessione sulla forma epistolare: permette una maggiore libertà di espressione, una maggiore confidenza, utile per un viaggio nell’interiorità di entrambi i protagonisti?
Penso di avere già risposto in larga parte. La forma epistolare non solo permette una maggior libertà di espressione, ma è genuina ed autentica (a meno che uno dei corrispondenti si proponga sin dall’inizio di destinare poi il carteggio alla dimensione pubblica, ma non fu questo il caso).
Devo però aggiungere, per smorzare entusiasmi non giustificati, che questa corrispondenza non produsse una profonda confidenza, nonostante la sua durata trentennale. Lo scrissi in una pagina del libro: “ci scriviamo da tanti anni, ma ci conosciamo poco ….”: ma nemmeno quell’invito sortì un grande effetto. Credo che ciò sia dovuto al fatto che eravamo entrambi bloccati, per motivi diversi. Salvatore perché penso sia restio ad analizzare la sua parte emotiva o sentimentale: c’è in lui un vissuto tragico nell’età giovanile che vuole espressamente dimenticare, e che fa da freno ad ogni auto-analisi e quindi ad ogni apertura. Ed io per un rispetto dovuto all’asimmetria delle nostre posizioni. Per quanto dicessi e volessi, io ero pur sempre il magistrato, l’autorità, l’artefice delle situazioni: ogni mia sollecitazione ad aprirsi, sia pure su territori personali e non legati all’ambiente, poteva essere vista come un’invadenza indebita. Un paio di inviti molto misurati, da parte mia, non ebbero risposta se non minima, e desistetti. Ciò non toglie che una conoscenza abbastanza profonda sia maturata in entrambi, ad onta del silenzio su temi intimi, perché anche un parlare lontano da questa sfera, alla lunga finisce con il manifestarla. Almeno lo credo e lo spero.
Il percorso del Perdono per chi ha commesso reati gravi è possibile, ma richiede tempo: quali sono le fasi che lo rendono possibile?
Il perdono, come lo dobbiamo intendere correttamente, è una relazione tra offeso ed offensore, quindi è un fatto estraneo al nostro rapporto. Paradossalmente, era se mai Salvatore a dovermi “perdonare”, poiché io ero la causa istituzionale delle sue sofferenze: ma lui sgombrò subito il campo da questa ambiguità, perché nella prima lettera, in risposta alla mia accompagnata dal dono di un libro, mi scrisse: “presidente, io lo so che lei mi ha dato l’ergastolo perché lo dice la legge, ma lei nel suo cuore non me lo voleva dare; e io la ringrazio e le dico che che farò come lei mi consiglia ….”.
Allora, se ci spostiamo nel territorio della maturazione interiore, il concetto di “perdono” si accompagna, anzi di regola deve essere preceduto, da quello di “pentimento”. “Perdono” e “giustizia”, – ha scritto Paul Ricoeur – possono conciliarsi solamente tenendo distinti i due piani, il primo concernendo il livello delle relazioni interpersonali, il secondo la sfera dei rapporti sociali o istituzionali. Il perdono nell’ambito istituzionale non esiste, se non come insieme degli istituti di mitigazione della pena inflitta, nelle situazioni previste dalla legge (dall’indulto alla semi-libertà, dalla liberazione condizionale al permesso premio, ad altre forme ancora).
Cosa diversa è il per-dono da parte dell’offeso, cioè, a ben guardare, il dono massimo che un individuo può offrire, perché è la rinuncia ad un impulso profondo ed innato, ed esprime la sua capacità di superare il proprio risentimento in nome della com-passione. La legge, su questo piano, si astiene dall’intervenire, pur considerando positivamente l’avvenuto perdono quando si tratta di mitigare la pena attraverso gli istituti di legge.
Il perdono da parte della legge (che può manifestarsi nelle forme dette sopra) ha un diverso percorso e una diversa fisionomia: esso è tarato su una disposizione della nostra Costituzione, la quale afferma che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Perciò le forme anzidette di mitigazione della pena vengono praticate nella misura in cui si ritiene che la rieducazione sia avvenuta.
Ora il sintomo più convincente di questa rieducazione è il pentimento, cioè il rifiuto dei valori e dei modelli che hanno generato il delitto, per far posto all’accoglimento di valori positivi. Quando ciò avvenga è difficile dire con certezza, poiché si tratta di un percorso interiore: ma vari sintomi sono affidabili; e soprattutto l’esperienza offre una ragionevole certezza che il tempo lavora l’interiorità di ciascuno, perché tutti siamo attraversati dal tempo, e con il tempo cambiamo: nelle nostre cellule, che in parte si rinnovano ogni giorno, e nei nostri orientamenti, che mutano con la maturazione legata al tempo dell’espiazione.
Lo sgrammaticato Salvatore e il giudice, competente e sensibile, fanno parte della stessa umanità, ma uno dei due l’ha persa per un certo periodo della propria vita. Quali norme carcerarie andrebbero riviste per garantire la giustizia e recuperare il detenuto?
Salvatore e il giudice sono in effetti esponenti di mondi molto diversi. Ma il loro contatto realizza, senza che nessuno dei due se sia proposto e senza che lo abbia neppure pensato, il tipo di incontro desiderabile tra chi ha commesso il delitto e la comunità esterna.
L’ergastolo, a pensarci, è una pena terribile, anche se non ha la crudeltà spaventosa dei supplizi. Significa che non è più permesso sperare. Noi possiamo sopportare una sofferenza anche grande se ci afferriamo al tempo necessario perché essa abbia termine. Può essere un mese, un anno, anche dieci o vent’anni, ma sappiamo che, se ci aggrappiamo a quel terminale, ogni giorno ingoiato ci avvicina se non altro alla sua fine.
Nell’ergastolo, nel “fine pena: mai”, questo non accade. Il futuro desiderabile non esiste. Tutto il resto della nostra esistenza sarà così, estraneo a noi stessi. Per questo la lettera del giudice, frutto di un gesto impulsivo e poi replicata in una corrispondenza anch’essa senza fine, assume il significato di un patto tacito, mai esplicitato e neppure percepito all’inizio: tu, Salvatore, sei chiamato ad affrontare una prova durissima, ai limiti delle forze umane; io ti accompagnerò, tu resisterai. I due mondi lontani possono incontrarsi in questa dimensione.
Ma allora – è la domanda conseguente – se l’ergastolo è questa pena spaventosa, è davvero necessario conservarlo? Di più: è davvero necessario il carcere medesimo?
Molti rispondono di no. Abolire il carcere è una richiesta che ritorna da decenni, perché il carcere non rieduca, perché chi lo subisce esce peggiore anziché migliore, e per altre varie motivazioni. Poi, però, anche chi enuncia queste tesi, messo di fronte a crimini ripugnanti, ammette che “in certi casi” il carcere è inevitabile.
Per i delitti gravi non si può chiedere alla comunità di perdonare o di dimenticare subito: il crimine è un trauma profondo, occorre del tempo perché il corpo sociale elabori il lutto, e perché chi lo ha commesso ne avverta l’orrore. C’è un tempo del delitto e c’è un tempo dell’espiazione. Solo con il tempo la comunità elabora il lutto e diventa disponibile a riconoscere l’umanità dell’espiante, solo con il tempo il condannato accoglie un diverso modo di guadare il mondo e le relazioni con i suoi simili.
Dunque si può dire che in presenza di condotte che offendono profondamente il sentire etico di una comunità, una sanzione è necessaria, e fino ad oggi non si è riusciti a pensare a niente di meglio del carcere, essenzialmente perché la libertà personale è l’unico bene che tutti posseggono, e la cui privazione può essere modulata in ragione della gravità del delitto commesso.
Ma la comunità che, per il tramite dell’istituzione, infligge il carcere, deve poi chiedere anche a se stessa di essere capace di riaccogliere il carcerato quando sarà mutato. Perciò deve seguire il percorso del condannato, e modulare la pena in funzione di quel percorso, oltre che accompagnarlo in quella pesante traversata del tempo. In parte avviene già, ma molte rigidità possono essere attenuate.
Questa è la prima riforma, che passa non tanto attraverso norme nuove, quanto attraverso una maturazione culturale collettiva. Il detenuto, prima o poi, tornerà in mezzo ai suoi simili: è interesse di tutti che non vi torni esacerbato e indurito dalla pena, ma cresciuto ed accolto nella sua dimensione di cittadino.
In secondo luogo, occorre condurre uno sforzo maggiore per ridurre la pena carceraria, sostituendola con altre forme di sanzione quando essa non è assolutamente necessaria
Pertanto, abbandonate ipotesi radicali impraticabili, la cosa più ragionevole, è quella di trovare un’intesa su quali crimini giustifichino il carcere; a quali altri si addicano sanzioni intermedie, che limitano la libertà ma non totalmente e non in forme detentive (sono molte, e i più non lo sanno: la detenzione domiciliare, l’affidamento in prova, la libertà controllata, le prestazioni di pubblica utilità: la quantità di soggetti che scontano una di queste sanzioni è oggi di dimensioni comparabili a quella che è soggetta alle pene intra-murali); e che cosa sia opportuno fare una volta ridotta all’essenziale la quantità di delitti cui si conviene il carcere.
Fra tutte queste tipologie di sanzioni quelle che hanno un reale valore rieducativo, e soprattutto producono un senso di riconciliazione con la comunità esterna, sono le prestazioni di pubblica utilità: esse infatti trasmettono un significato di restituzione, e quindi di riconciliazione con la comunità; e solo esse possono applicarsi anche a situazioni di media gravità, e non bagattellari, come oggi avviene, graduando la vigilanza in proporzione alla necessità. Ma il tutto esige uno sforzo organizzativo che evidentemente non si riesce a mettere in piedi, posto che da decenni la richiesta viene apprezzata ma non soddisfatta.
Se fosse praticato su più larga scala, questo tipo di sanzione produrrebbe un deciso sfoltimento delle prigioni, e di riflesso un innalzamento del livello di trattamento del residuo cui si continuerebbe ad applicare la detenzione intra-murale.
Chissà che la vicenda di Salvatore, e l’inevitabile domanda che essa suscita sull’opportunità o meno di conservare l’ergastolo, non riesca a produrre una maturazione collettiva, e soprattutto un’azione in questa direzione.