L’infanzia nelle guerre del Novecento. Alcune domande al Prof. Bruno Maida
L’infanzia nelle guerre del Novecento (Einaudi).Nei disegni di guerra fatti dai bambini le strade sono molto rare e non collegano mai due luoghi. Tutto si riduce a un punto dove c’è il corpo senza vita di qualcuno oppure un veicolo brucia. Metafora di una vita sospesa, l’assenza di strade rinvia alla responsabilità degli adulti che devono costruirle e aiutare i bambini a ritrovarle. La guerra è una frattura profonda nella vita di chi ne faccia esperienza, condiziona i comportamenti successivi, sedimenta le memorie che si radicano nell’identità. Lo è ancora di più per l’infanzia per la quale, nella stratificazione delle diverse età che la compongono, la guerra coincide con il tempo della formazione, della definizione di se stessa, della costruzione di un proprio sguardo sul mondo. Che siano stati mobilitati, resi protagonisti passivi o attivi della violenza, colpiti da traumi e perdite, rimasti soli oppure, al contrario, attraversino il tempo della guerra protetti e non invasi dagli effetti più laceranti, i bambini sono stati in ogni caso sempre più coinvolti e condizionati dai conflitti armati del Novecento e gettati sulla scena fino a trasformarsi, nella seconda metà del secolo, in veri e propri combattenti. E ciò è accaduto all’interno di un paradosso: all’affermarsi e al diffondersi di un sistema di protezioni nazionali e internazionali per i civili nei contesti di guerra, con un’attenzione specifica nei confronti dei bambini, è corrisposto un progressivo e crescente coinvolgimento diretto e indiretto dell’infanzia.
Associazione per i Diritti umani ringrazia moltissimo il Prof. Bruno Maida per il tempo dedicatoci.
Lei è sempre attento ai diritti dell’infanzia: da dove nasce l’interesse per questa parte della società?
La storia dell’infanzia non ha mai avuto grande fortuna tra gli storici, ancor meno tra i contemporaneisti. Eppure io ritengo che definire il Novecento il “secolo dei bambini” non sia un guscio vuoto o un’espressione retorica. Il secolo trascorso ha conosciuto una profonda trasformazione per ciò che riguarda l’infanzia: la scolarizzazione di massa, la nascita della pediatria, la lotta vittoriosa contro il lavoro minorile, la costruzione di un sistema di norme per la protezione dei bambini durante le guerre sono tutti aspetti di un processo di miglioramento nelle condizioni dell’infanzia. Nello stesso tempo, però, vanno tenute in considerazione due questioni: la prima è che l’insieme di questi cambiamenti ha riguardato quasi esclusivamente l’Occidente; la seconda è che la protezione dei civili e, nello specifico dei bambini, nelle guerre si è accompagnato, come non mai, a un loro massiccio coinvolgimento e morte di massa. I bambini sono diventati sempre più vittime, attori e spettatori dei processi sociali, in tempo di pace e di guerra. Non considerare il loro punto di vista, la loro esperienza, la loro memoria significa negarsi la comprensione di una parte importante della storia vissuta dalle generazioni che ci hanno preceduto ma anche del presente.
Quali sono le differenze tra la tutela dei bambini durante le principali guerre del Passato e quelle contemporanee?
Nel passato i civili non erano coinvolti in modo massiccio nelle guerre mentre le caratteristiche dei conflitti contemporanei hanno modificato profondamente il loro ruolo, a causa sia della mobilitazione totale che ogni paese ha realizzato sia delle trasformazioni strategiche e tecnologiche che hanno determinato un sempre maggiore numero di morti tra la popolazione e sempre meno tra i militari. Questo coinvolgimento ha prodotto un insieme di norme, a partire dalla fine dell’Ottocento, affinché i civili fossero protetti e tra essi una particolare attenzione, dopo la prima guerra mondiale, è stata rivolta all’infanzia. Insomma, la vera questione non sono le tutele, perché guardando il ramificato sistema di accordi e leggi internazionali a protezione dei bambini nelle guerre contemporanee la prima impressione è che esistano tutti gli strumenti in grado di limitare al massimo il coinvolgimento dell’infanzia. Il punto è la loro applicazione perché molti paesi non rispettano le convenzioni internazionali, molti altri sono complici attivi o passivi. Il caso più evidente è il divieto di vendere armi ai paesi che utilizzano bambini-soldato, divieto che è stato assai poco rispettato dagli stessi stati firmatari.
Nel suo libro dà voce ai bambini attraverso parole, disegni, giochi: cosa ci chiedono? Come possiamo intervenire?
I bambini chiedono di poter vivere una vita normale, con i propri genitori, amici, una casa e del cibo dignitosi, imparando e studiando. Ognuno all’interno delle tradizioni, abitudini, culture che esistono alle diverse latitudini. Quello che gli adulti devono fare è garantire e difendere quella normalità perché nell’infanzia si deposita il progetto di trasmissione culturale che ogni società definisce e costruisce. Le guerre spazzano via tutto questo e accelerano artificialmente i processi della formazione e del passaggio tra le diverse età; spesso cancellano l’esperienza stessa dell’infanzia come la intendiamo. I livelli di interventi sono molti e diversi. Verrebbe da dire, per esempio, che sarebbe bello vivere in un mondo dove non debba esistere Save the Children o Action Aid. Ma la verità è che le organizzazioni non governative, al di là di qualsiasi critica che possa essergli rivolta, hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo di supplenza essenziale rispetto all’immobilismo e al disinteresse degli Stati nazionali.
Qual è, per lei, il significato del concetto di “resilienza”?
Resilienza è una parola molto diffusa, direi abusata. Come tutti i concetti che hanno fortuna, finiscono per essere non solo semplificati ma banalizzati. Quando si parla di resilienza, secondo me, è necessario tenere in considerazione due aspetti. Il primo è il rapporto con il trauma, che significa contestualizzare le condizioni in cui il bambino ha vissuto, conoscerne il contesto familiare e sociale, far emergere il più possibile l’esperienza del bambino, le sue paure e le sue speranze. Il secondo è che ogni forma di resilienza necessita di un ambiente resiliente, di persone, strutture, condizioni, che favoriscano lo svilupparsi delle risorse e delle possibilità che esistono nelle persone. La resilienza – mi viene da dire, tenendo conto che il mio mestiere è lo storico, non l’educatore, lo psicologo o il pedagogista – ha bisogno di una comunità resiliente, capace di appoggiare, restituire e condividere il mondo della sofferenza con cui un bambino, quando subisce un trauma o meglio una serie di ferite, deve confrontarsi. Le guerre non si esauriscono, per esempio, solo nella dimensione della morte – che costituisce comunque un’esperienza radicale e devastante – ma producono una desertificazione materiale e psicologica di cui bisogna tenere conto e che pervade tutto il tempo e lo spazio della ricostruzione della società. Bisogna evitare che i bambini si trovino nella condizione di Edmund, il protagonista di Germania anno zero che giunge al suicidio non solo per la sua disperazione individuale ma anche perché intorno a lui vede solo le macerie fisiche e umane della guerra, un deserto che gli appare senza speranza.

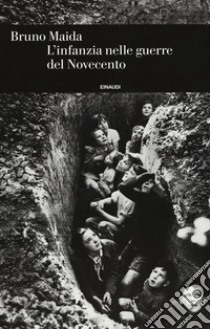
















Una risposta
[…] L’intervista sul mio libro L’infanzia nelle guerre del Novecento, per il sito http://www.peridirittiumani.com/2018/01/09/linfanzia-nelle-guerre-del-novecento-alcune-domande-al-pr… […]