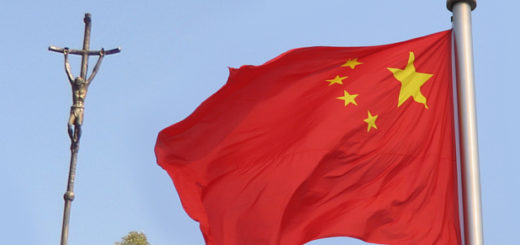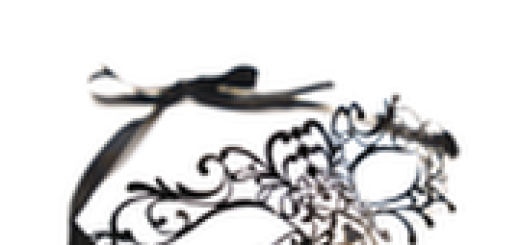La vittoria di Erdoğan
di Alberto Gasparetto (CIPMO. Centro Italiano per la Pace in Medioriente)
Recep Tayyip Erdoğan ha vinto. Le elezioni tenutesi ieri, domenica 24 giugno 2018, verranno ricordate come un evento cruciale nella storia recente della Turchia e nel percorso politico del suo principale protagonista. Il trionfo è stato duplice. Innanzitutto, sbaragliando la flebile concorrenza di un’opposizione presentatasi divisa alle elezioni presidenziali, si è riconfermato capo dello Stato, carica che detiene ormai dal 2014, ottenendo il 52,7% dei consensi ed evitando il temuto ballottaggio che avrebbe potuto offrire qualche chance al secondo classificato, il laico Muharrem Ince del Partito Repubblicano (CHP). In secondo luogo, il suo AK Parti ha ottenuto il successo anche alle elezioni per il Parlamento arrivando al 42,4%, pur in significativo calo rispetto alle elezioni del novembre 2015 (49,5%). Tuttavia, grazie all’accordo pre-elettorale denominato “Alleanza del Popolo” siglato con il nazionalista MHP e l’ultranazionalista-islamista BBP, è riuscito a prevalere anche in Parlamento, dove la coalizione ha ottenuto complessivamente il 53,6% dei consensi, pari a 342 seggi su 600 e lasciando all’”Alleanza della Nazione”, formata dal CHP, il Partito buono (IYI), il Partito della felicità(Saadet) e il Partito democratico (DP), solamente 191 seggi.
Risulta premiata, anche se per un soffio, la scelta del partito filo-curdo HDP di presentarsi da solo visto che, a dispetto della politica repressiva portata avanti da Erdoğan negli ultimi anni e che ha portato all’incarcerazione di molti suoi esponenti fra cui il suo Presidente Selahattin Demirtas, è riuscito a superare la vituperata soglia di sbarramento del 10%, spedendo in Parlamento 67 membri. Da registrare l’exploit personale di Ince che alle presidenziali ha ottenuto il 30% dei consensi, pur fermandosi il suo CHP al 22,7%. Una differenza di ben 8 punti percentuali che, in assenza di uno studio dei flussi elettorali al momento non così puntuale, va probabilmente ascritto al modesto risultato conseguito dalla candidata del IYI, Meral Aksener (fuoriuscita dal MHP quando il suo presidente Devlet Bahceli decise di sostenere la riforma costituzionale voluta da Erdoğan) e dello stesso Demirtas che supera appena l’8%.
La geografia del voto (link), d’altra parte, risulta pesantemente univoca. Sulle due cartine che la descrivono campeggia un giallo di matrice inequivocabilmente erdoganiana. Fanno eccezione solamente la strisciolina verticale in corrispondenza della costa occidentale mediterranea, con prevalenza di voti al CHP e l’immancabile zona sudorientale a maggioranza curda. Particolarmente significativo è anche il voto nelle due principali città del Paese, Istanbul e Ankara: Erdoğan ha personalmente ottenuto oltre il 50% dei consensi, mentre l’AK Parti risulta primo in tutte e tre le circoscrizioni in cui è stata suddivisa la megalopoli sul Bosforo (fra il 41 e 45%) e in due su tre nella capitale (dove comunque è attorno al 40%).
In queste ore, i partiti usciti sconfitti dalla competizione elettorale stanno difficilmente mandando giù un esito che alcuni non prevedevano così schiacciante. Fa eccezione l’HDP, che festeggia la storica permanenza in Parlamento nonostante tre anni di vessazioni cominciate nell’estate 2015 e proseguite con la destituzione l’anno successivo di 50 parlamentari su 59, accusati di favoreggiamento delle attività terroristiche di marca PKK, per effetto della rimozione dell’immunità parlamentare. Eppure, nonostante le denunce di brogli e manipolazioni e di una conduzione non equa della campagna elettorale (Erdogan controlla la stragrande maggioranza dei mezzi di comunicazione), le opposizioni hanno notevoli responsabilità nell’aver mancato di proporre un’alternativa valida al predominio di Erdoğan e dell’AK Parti. A loro parziale discolpa, il fattore temporale. Progressivamente dato in calo nei consensi – a causa del crollo vertiginoso della lira turca e della conseguente perdita del potere d’acquisto da parte dei consumatori, dell’inflazione a doppia cifra e della crescente disoccupazione – Erdoğan ha infatti convocato con largo anticipo le due contestuali consultazioni rispetto alla data prevista per il novembre 2019. Ha sostanzialmente inteso evitare di dover render conto soltanto fra un anno e mezzo ad un elettorato che sarebbe stato verosimilmente danneggiato dalle conseguenze di una crisi economica che sarà comunque chiamato a gestire. Pertanto, meglio puntare tutto sull’ormai consolidata ricetta nazionalista, verbalizzata dall’alleanza pre-elettorale con l’MHP (e il BBP). Inoltre, le circostanze sembrano ricalcare lo scenario di tre anni fa quando, per effetto della crisi economica, il voto del giugno 2015 aveva consegnato al Paese un Parlamento diviso e, per la prima volta dal 2002, senza una maggioranza assoluta. Erdoğan dovette il grande successo nel novembre 2015 al fatto di apparire quale unico uomo politico capace di infondere sicurezza nel popolo turco, avendo guidato il proprio Paese lungo una crescita economica e d’influenza politica regionale senza precedenti. Anche oggi, al netto di eventuali manipolazioni, il popolo turco ha scelto l’unica persona di cui si fidano, con la quale c’è ormai un rapporto di filiazione e di affetto. E’ l’unico i cui proclami contro l’uscita dalla crisi economica vengono accolti con fiducia; l’unico apparentemente in grado di riportare la Turchia al centro della scena internazionale soprattutto considerando l’evoluzione della situazione siriana; l’unico capace di far sentire la propria voce dinanzi ad un’Unione Europea percepita come ostile nella questione del ricollocamento dei migranti, nonché come traditrice del lungo e agognato sogno di diventarne membro effettivo.
Il quadro che ne scaturisce è quello di una Turchia che appare totalmente nelle sue mani, anche per effetto della riforma costituzionale del 2017 che, abolendo la carica di primo ministro, accentra pesantemente il potere esecutivo nelle mani del capo dello Stato, prefigurando formalmente il passaggio da un sistema parlamentare ad uno presidenziale ma, nei fatti, preludendo all’instaurazione di un sistema semi-autoritario ove mancano alcuni fondamentali contrappesi, quali potevano essere una magistratura indipendente, un sistema dell’informazione libero, un mondo accademico e intellettuale ancora vivo e capace di esprimere la propria opinione senza timore di repressioni. Ecco, in un clima da caccia alle streghe, con le epurazioni nelle forze armate e con lo stato di emergenza rinnovato per la settima volta, sarebbe stato interessante osservare i destini del Paese qualora in un Parlamento non esautorato dei propri poteri fossero prevalse le forze di opposizione. Sfortunatamente non verremo accontentati.