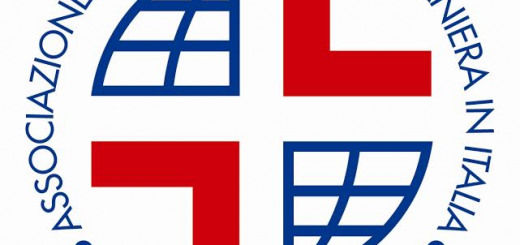Mai più. La vergogna italiana dei lager per immigrati
Con il settimanale Left è da poco uscito il libro “Mai più. La vergogna italiana dei lager per immigrati” avente come tema la detenzione amministrativa dei migranti “irregolari” in Italia, dai CPTA ai CPR. Si tratta di un tentativo di raccontare oltre 20 anni di abusi, di fallimenti, di vicende che poco sono state raccontate e che poco, ad avviso di chi lo ha realizzato, rendono onore alla storia democratica di questo paese.
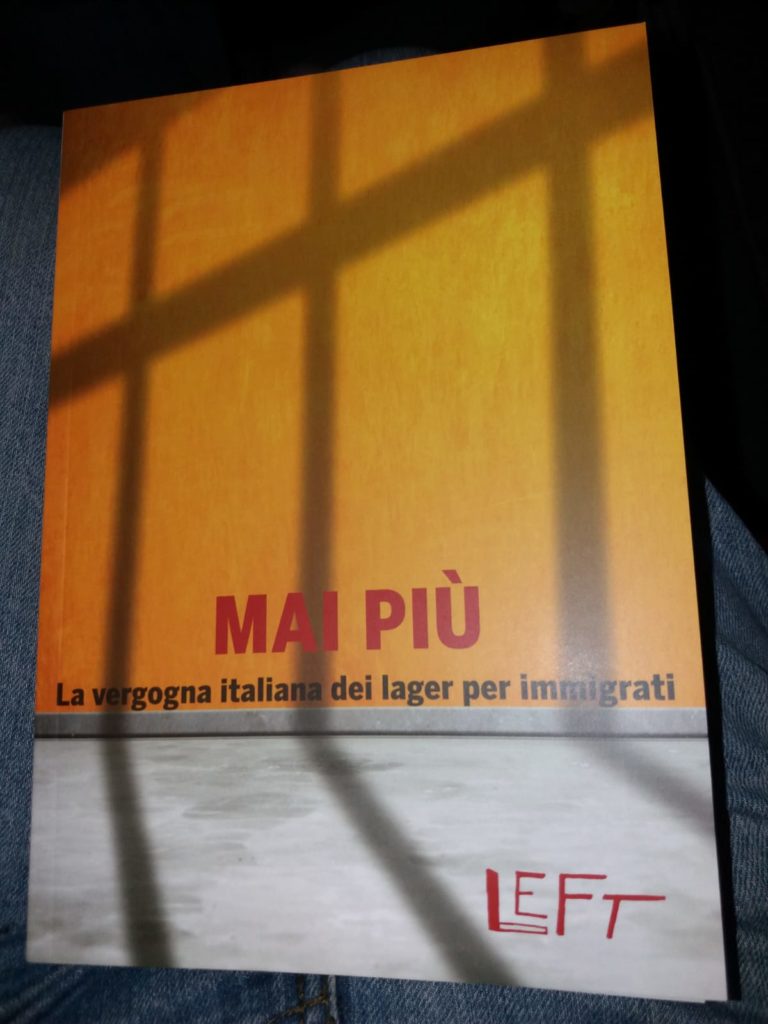
A cura di Yasmine Accardo (Campagna LaciateCI entrare) e Stefano Galieni (Adif, Assoicazione Diritti e Frontiere)
Ecco l’introduzione al testo:
“Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza” fu il nome che venne dato alle prime strutture di detenzione amministrativa per migranti sorte in Italia dopo l’approvazione della legge Turco-Napolitano. Correva l’anno 1998 e già da allora si diceva nel centro sinistra, che bisognava coniugare “accoglienza e sicurezza”, ponendo l’accento sempre più sul secondo termine. I CPTA, acronimo delle strutture (ma la A di assistenza venne dimenticata), vennero realizzati in maniera improvvisata prima ancora di dare loro un quadro normativo.
Per la prima volta nel nostro paese, nel resto d’Europa era già prassi, si poteva privare le persone della libertà personale in virtù del fatto che la loro presenza non era considerata regolare. La finalità dei centri riguardava gli “stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera non immediatamente eseguibile”. Persone che non avevano commesso reati ma rinchiuse per ciò che erano. Per facilitare i rimpatri delle persone non gradite, l’allora ministro dell’Interno Giorgio Napolitano si affrettò a siglare i primi accordi bilaterali di riammissione con alcuni paesi del Nord Africa che raramente produssero i risultati sperati.
I centri, in cui si poteva restare rinchiusi fino ad un mese in attesa dell’espulsione, nacquero da un giorno all’altro e senza organicità. A Lampedusa, non c’era ancora la struttura di Contrada Imbriacola quindi le persone venivano tenute nei pressi dell’aeroporto e poi di un’ex base militare. Non risultava inquadrato come CPTA ma di fatto la sua funzione era quella. A Trapani venne preso in affitto un ospizio in disuso, il Serraino Vulpitta, e ci si realizzarono delle celle, a Roma si utilizzò parte di una caserma nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino, a Ponte Galeria, e poi Agrigento, Bari, Brindisi. Già da allora i servizi di “assistenza” (sanità, pasti ecc.) vennero dati in gestione a imprese o cooperative che a volte partecipavano a gare pubbliche, più spesso ottenevano un affidamento diretto, con un business enorme. La sorveglianza esterna e la repressione interna in caso di emergenze era (come ancora oggi) gestita dalla locale prefettura e quindi attraverso personale dei diversi corpi dello Stato. Anche per questo furono in molti a “offrirsi” per fornire strutture adeguate, da Don Cesare Lo Deserto che fece rapidamente trasformare il suo centro Regina Pacis, prima adibito all’accoglienza, in un CPT, alle città di Milano (Via Corelli), Torino, (Corso Brunelleschi), Bologna (Via Mattei). A Modena ne sorse uno gestito dalle Misericordie il cui presidente, Daniele Giovanardi, fratello gemello del più noto uomo politico, non nascondeva pubblicamente di usare gli introiti ricavati per acquistare le ambulanze dell’ospedale di cui era primario. E poi Foggia, Crotone (Isola Capo Rizzuto) accanto a un immenso campo di accoglienza, Lamezia Terme, (gestito da un responsabile della protezione civile al posto di una comunità di accoglienza per tossicodipendenti). Nel 2006 si aprì il CPT di Gradisca D’Isonzo, ribattezzata la “Guantanamo italiana” per l’uso di tecnologia avanzata atta a impedire fughe, rivolte, socialità eccessiva fra gli “ospiti”. Sì perché chi vi era trattenuto non era considerato detenuto ma “ospite” al punto che se riusciva a fuggire, nonostante si scatenassero le caccie all’uomo, i responsabili per negligenza non potevano essere perseguiti. A Ragusa ne aprì uno solo per donne in pieno centro della città con telecamere interne alle stanze delle “ospiti” e con personale quasi esclusivamente maschile, chiuse quello di Agrigento per difficoltà di gestione e ne venne aperto uno a Caltanissetta (località Pian Del Lago), si spostò quello di Bari, per pochi mesi ne restò aperto uno a Trieste mentre nelle altre città si rese difficile la loro realizzazione sia per l’opposizione degli enti locali più spesso perché popolazione, movimenti sociali (insieme a difficoltà di reperire strutture idonee), ne impedirono la realizzazione, come nel caso di Corridonia, nel maceratese. Nel frattempo era entrata in vigore la Bossi–Fini, che raddoppiava i tempi massimi di trattenimento (da 30 a 60 giorni) ma si andava rapidamente dimostrando il fallimento di tale approccio all’immigrazione. I centri sin dalla loro apertura si erano dimostrati luoghi da cui si tentava di fuggire e in cui si moriva. La notte di Natale del 1999 veniva trovato morto, nel CPT di Ponte Galeria, Mohamed Ben Said, mascella rotta e forse imbottito di psicofarmaci. Pochi giorni dopo, il 28 dicembre, alcuni “ospiti” tentarono la fuga dal “Serraino Vulpitta” di Trapani, vennero ripresi, rimessi in cella e, sembra, uno di loro riuscì a dar fuoco al materasso. Non si trovarono le chiavi per aprire e in 6 trovarono una morte atroce (uno di loro dopo 3 mesi di agonia), non funzionavano gli estintori, insomma una strage annunciata in una struttura anche inadeguata al trattenimento.
C’è un calcolo macabro scomparso dalla storia ufficiale, quello di coloro che hanno perso la vita a causa della detenzione in questi spazi in cui non valevano e non valgono nemmeno le garanzie dei regolamenti penitenziari. Fra tentativi di fuga, mai chiariti malori, suicidi parliamo, per difetto, di una trentina di morti. Senza contare gli innumerevoli atti di autolesionismo, gli equilibri psicofisici spezzati da mesi di privazione della libertà, la repressione sempre seguita a rivolte e sommosse per la qualità del cibo, per avere colloqui con parenti e avvocati, per difficoltà strutturali derivanti da spazi pensati esclusivamente come zoo temporanei per persone.
Per parecchi anni, soprattutto fino al 2007, si sono realizzate mobilitazioni per chiedere la chiusura dei centri, giudicati dai più irriformabili, la più grande a Torino nell’inverno 2002, ma tante e in tutte le città in cui c’erano CPT o in cui si minacciava di aprirli. Mobilitazioni a volte creative e che riuscivano a parlare alla popolazione e alle persone rinchiuse, in altri casi aspramente e duramente conflittuali, spesso represse dalle forze dell’ordine.
Ma anche nei palazzi della politica, per alcuni anni, ci si interrogò sul senso di queste strutture che non sono state “imposte dall’Europa” come ha lasciato passare una vulgato pseudo progressista (l’Europa con Schengen ha solo chiesto a ogni Stato di vigilare sui propri confini), ma create più per soddisfare esigenze propagandistico securitarie che già da allora venivano utilizzate da buona parte del parlamento. Ci furono però parlamentari, senatori ed europarlamentari che cominciarono, essendo gli unici ad avere il mandato ispettivo, a visitare quei luoghi, a denunciarne le carenze e le condizioni di vita che vi venivano imposte, a provare a scardinare questo sistema. Certo, di centri ce ne erano in tutta Europa, nel 2005 (fonte Migreurop) 174, in Italia si arrivò a un massimo di 14 strutture che costarono milioni di euro l’anno e che, anche in base agli scopi per cui erano stati aperti si dimostrarono fallimentari. I dati di 14 anni fa indicano come al massimo il 48% delle persone trattenute veniva poi effettivamente rimpatriato con costi che si aggiravano attorno agli 8000/12000 euro per ogni espulsione. Il tutto per detenere 2000/3000 persone l’anno, rispetto ai dichiarati “500 mila clandestini”, in parte rinchiusi nei centri dopo periodi di detenzione in cui non erano stati identificati, i cui provvedimenti di convalida del trattenimento erano affidati a giudici di pace (mai utilizzati finora per autorizzare la limitazione della libertà personale) e che, una volta non rimpatriati, tornavano fuori in condizioni di irregolarità con l’obbligo di lasciare entro pochi giorni il territorio nazionale ma senza alcun paese intenzionato ad accoglierli.
Solo propaganda insomma e costruzione della fortezza escludente per rinchiudere il “nemico interno” e dimostrare che lo Stato si prende cura della sicurezza dei cittadini. Oltre che gli ex detenuti sono finiti nei centri persone che avevano perso il lavoro e quindi il diritto di restare in Italia, richiedenti asilo a cui non era stata riconosciuta la protezione internazionale o umanitaria, lavoratori e lavoratrici al nero (in particolar modo nel lavoro di cura), vittime di tratta per sfruttamento sessuale che non usufruivano delle normative atte a tutelarle, a volte persino minori.
Nel 2006 venne istituita una Commissione indipendente per analizzare il funzionamento dei CPT, presieduta dal diplomatico Staffan De Mistura, che presentò un suo rapporto il 1 febbraio del 2007. La conclusione era pilatesca: i CPT non dovevano essere chiusi ma “superati”, riducendo al minimo il numero delle persone da trattenere, il tutto proprio mentre si riconosceva il fallimento di tali strutture. Nel 2009 col cambio di governo, il nuovo ministro dell’Interno, Roberto Maroni, incentivò invece l’utilizzo dei trattenimenti. I CPT cambiarono acronimo diventando CIE (Centri per l’Identificazione e l’Espulsione) rompendo almeno una ipocrisia di fondo e si portò a 6 mesi il tempo massimo di trattenimento, trasformandoli di fatto in carceri senza neanche gli elementi propri di un sistema penitenziario e dando via così a un ciclo di rivolte e sommosse. Non solo non aumentò il numero dei rimpatriati (per gli stessi funzionari di polizia chi non è identificato nei primi 15 giorni raramente riesce a rientrare nei programmi di rimpatrio coattivo), ma aumentarono le rivolte e le sommosse, ancora monitorate da società civile e meno dalla politica. Uno degli aspetti poco considerati di quel periodo riguarda il cospicuo business dei CPTA. In ogni città in cui se ne creava uno era la locale prefettura a definire l’ente gestore, raramente con gara pubblica d’appalto, col risultato che c’erano centri in cui il costo di un trattenuto al giorno era di 72 euro (Modena, Misericordie di Daniele Giovanardi) e altri in cui si scese a 26 euro (Malgrado Tutto, Lamezia Terme). Si aggiunga il costo della vigilanza, affidato ai vari corpi militari e di polizia dello Stato e l’indennità percepita da ogni prefetto della città in cui nasceva un centro. In molte strutture poi, per garantire i servizi, si giunse a definire una clausola per cui, anche in caso di centro poco affollato, l’ente preposto percepiva giornalmente la somma spettante qualora i presenti fossero il 50% +1 dei posti stabiliti. Impossibile rimetterci insomma.
Nel 2011 il governo arrivò a vietare a giornalisti, operatori di organizzazioni umanitarie non accreditati, amministratori locali e a tutte le altre figure esterne, l’accesso ai CIE. Da un appello di alcuni operatori dell’informazione raccolto dalla Federazione Nazionale della Stampa e dalla mobilitazione di settori sensibili di società nacque la campagna “LasciateCIEntrare” che tentò di riportare l’attenzione su questo buco nero in cui non debbono affacciarsi scomodi testimoni.
Il governo successivo, con la ministra Cancellieri, sospese l’efficacia della circolare che vietava l’accesso ai centri ma il potere di limitare le visite restò nelle mani dei prefetti. Nel frattempo furono tante le rivolte che scoppiarono e portarono a dover chiudere sezioni dei centri quando non le intere strutture. In poco tempo i CIE aperti si ridussero a 4, ma intanto si stava entrando già nel periodo vicino ai giorni nostri.
Il ministro Minniti rinominò i centri che diventarono CPR (Centri Permanenti per il Rimpatrio). Ci sono in tutti questi cambiamenti di acronimi modifiche normative che illustreremo in seguito ma il tentativo, da anni perseguito, è quello di aprirne almeno uno in ogni regione. A oggi (settembre 2019) le strutture aperte sono 7: Torino, Roma, Bari, Brindisi, Potenza (Palazzo S. Gervasio), Caltanissetta e Trapani (Contrada Milo), a cui vanno aggiunti gli hotspot, Lampedusa, Taranto, Pozzallo, che pur non avendo ufficialmente scopi di trattenimento finiscono con svolgere tale funzione.
Prima della crisi di governo si stava lavorando alacremente per riaprire i centri di Milano e di Gradisca D’Isonzo (Gorizia), quello rimasto aperto per pochissimi mesi di Santa Maria Capua Vetere nel Casertano, uno nuovo a Macomer in Sardegna e un altro nel bresciano. Progetti che potrebbero realizzarsi presto anche se chi tenta di aggiudicarsi gli appalti per la gestione si ritrova a fare i conti col fatto che i loro predecessori sono spesso finiti sotto inchiesta per reati vari, tanto dal punto di vista amministrativo (distrazione di fondi) quanto penale per il trattamento riservato agli “ospiti”.
Infine, menzioniamo due capitoli che meriterebbero da soli ulteriori e molto attenti approfondimenti. In autunno sono previste mobilitazioni per impedire la riapertura o la apertura di CPR, per denunciare quanto sta avvenendo dopo che, se si esclude un periodo in cui i termini massimi di trattenimento erano stati riportati a 3 mesi, sono attualmente a 180 giorni con alcune forze politiche che hanno chiesto di arrivare a 18 mesi di detenzione.
Il futuro dei CPR è incerto. Tutti i tentativi di dichiararli incostituzionali sono falliti seppure la stessa sovraordinante Direttiva Europea 115/2008 considera il trattenimento come una estrema ratio e non la norma. Il primo decreto sicurezza permette a oggi di trattenere chi risulta essere privo dei requisiti per restare in Italia anche in luoghi diversi dai “CPR” ritenuti idonei. Quali sono? Zone aeroportuali, camere di sicurezza, sezioni riservate di penitenziari? Tutto è oggi possibile salvo, per chi ne fa richiesta, potersi regolarizzare e uscire dall’invisibilità.
Le strutture di detenzione amministrativa sono state pensate e potenziate come adeguate a garantire i confini europei e la “sicurezza interna”, ma si sono rivelati enormi voragini in cui sparivano persone, soldi pubblici e moriva lo Stato di diritto. Una ragione in più per parlarne con maggior cognizione di causa e per tornare a chiederne a gran voce la definitiva abolizione anche in quanto istituzioni totali dove neanche i più elementari diritti delle persone possono essere rispettate.
Stefano Galieni
P.S. Il testo che segue e che proponiamo è un lavoro collettivo che non può esaurire quanto accaduto in 21 anni. Non troverete storie molto importanti e mancheremo di citare tante e tanti che nel corso degli anni si sono impegnati in lavori di ricerca, di informazione, di ascolto delle vicende qui narrate o che hanno dato vita a mobilitazioni di ogni tipo. Soggettività variegate che hanno provato a far sì che questo angolo nero di Storia italiana non venisse rimosso o dimenticato. Ma questa è soprattutto una storia di donne e uomini incontrati, anche per un solo momento nei Centri, in fuga, in ospedale, che in prima persona hanno pagato le conseguenze di un sistema ingiusto e non da ultimo, coloro che per queste ingiuste detenzioni hanno perso la vita. A loro è dedicato questo lavoro, perché nessuno possa più dire domani “io non sapevo”
l’introduzione al testo: