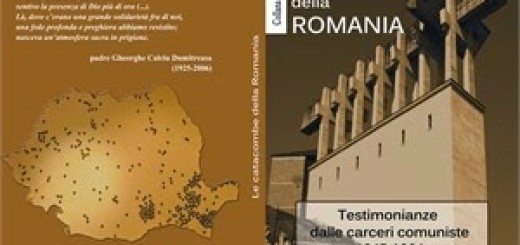La vita dei prigionieri di guerra e il Diritto internazionale umanitario

di Maddalena Formica
Nel contesto di un conflitto armato, i combattenti di una fazione vengono spesso catturati dalle forze nemiche e da queste vengono privati di libertà e posti, per mesi o anni, in campi di prigionia, dove le condizioni di vita possono essere particolarmente difficili.
Il diritto internazionale umanitario si è dunque interessato alla loro sorte, compiendo una distinzione tra coloro che sono stati privati di libertà nell’ambito di un conflitto armato internazionale, un conflitto che vede dunque opporsi due o più Stati, e quelli che invece sono stati catturati nell’ambito di uno conflitto non internazionale, dove ad opporsi sono invece uno Stato e un gruppo armato o due o più gruppi armati. Nel primo caso, il termine utilizzato dalla dottrina è in genere quello di vero e proprio “prigioniero di guerra”, nel secondo caso si tenderà a favorire invece l’espressione di semplice “detenuto”. La distinzione tra i due non è solo puramente terminologica ma, anzi, risulta nella pratica particolarmente importante poiché, se quasi nulla dice il diritto umanitario circa i diritti dei detenuti, una disciplina particolarmente protettrice è riconosciuta ai prigionieri di guerra.
LA FORTE TUTELA DEI PRIGIONIERI DI GUERRA NEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI
Nel quadro di un conflitto armato internazionale, tale statuto, innanzitutto, non può essere oggetto di rinuncia o essere perso dal soggetto che ne è beneficiario, anche qualora egli stesso abbia violato in precedenza disposizioni di diritto internazionale umanitario, ed è uno statuo che gli è automaticamente riconosciuto dal momento della cattura fino al momento del rimpatrio; in caso di dubbio circa il diritto ad ottenere tale statuto, inoltre, gioca una presunzione a lui favorevole, una presunzione che potrà essere superata solo nell’ambito di un procedimento giurisdizionale dinanzi ad un Tribunale.
La disciplina in materia di tutela dei prigionieri di guerra risulta essere inoltre particolarmente estesa nel momento in cui si affronta la gestione dello stesso campo di prigionia: tutti gli aspetti della vita dei prigionieri sono regolati in maniera precisa e tutte le disposizioni nel merito derivano da un generale obbligo di uguale ed umano trattamento a favore dei combattenti privati di libertà, a cui è quindi garantita una protezione massima.
Puntuali sono già le disposizioni circa la struttura stessa del campo: questi deve essere ad esempio posizionato in un luogo sicuro rispetto ai combattimenti, le evacuazioni in caso di emergenza devono essere possibili e il campo deve essere identificabile come tale (in genere sul tetto viene aggiunta la scritta “POW”” o “Prisoners of war” leggibile dall’alto) per evitare che venga colpito dalle forze nemiche. Standard minimi igienico-sanitari devono essere inoltre rispettati, così come garantite devono essere le cure mediche, le accortezze in materia di alimentazione, la possibilità di professare la propria religione e di ricevere lettere e pacchi dalla propria famiglia. Altre regole specifiche sono previste per proteggere bambini e donne (che ad esempio devono essere posti in locali diversi da quelli degli uomini) e in materia di lavoro: i prigionieri possono infatti svolgere attività ma non possono essere obbligati a lavorare se sono malati o feriti così come non possono essere obbligati ad arruolarsi o a partecipare in altro modo al conflitto.
Queste regole derivano dall’idea generale che essere della fazione opposta non costituisce un reato e che dunque l’essere prigioniero non deve inteso come una sanzione: condurre una vita “normale”, nei limiti del contesto del conflitto, deve essere dunque possibile.
Oltre a certe condizioni di vita, il diritto internazionale umanitario prevede e disciplina anche dei veri e propri meccanismi di garanzia dei diritti dei prigionieri di guerra, attivabili dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e dagli stessi prigionieri. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, innanzitutto, ha la possibilità di ispezionare i campi e di chiedere colloqui anonimi ai prigionieri per valutare le condizioni di vita ed eventualmente discuterne con coloro che ne sono responsabili; i prigionieri, invece, con piena immunità, possono allertare autonomamente la Croce Rossa, nominare un “uomo di fiducia” che li rappresenti e faccia valere i loro diritti e denunciare ai responsabili del campo eventuali situazioni contrarie alle disposizioni circa i già menzionati standard di vita individuati dalla Convenzione di Ginevra e dal relativo Protocollo I.
In genere, si può rilevare come, almeno nel contesto dei conflitti armati internazionali, le Parti tendano a rispettare nella pratica queste regole: oltre alle conseguenze di eventuali violazioni del diritto internazionale umanitario, infatti, gli Stati temono che condizioni di vita eccessivamente dure nei campi portino alla radicalizzazione dei nemici imprigionati così come a delle ritorsioni dell’avversario durante il conflitto.
LA SCARSA PROTEZIONE DEI DETENUTI NEI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI E LE PAURE DEL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA
Situazione molto diversa e, soprattutto, oggi sempre più preoccupante è quella invece dei detenuti, ovvero dei soggetti che hanno partecipato ai combattimenti nel contesto di un conflitto armato non internazionale e che hanno in seguito perso la propria libertà.
Pochissime sono infatti le disposizioni specifiche in materia previste dal Protocollo II della Convenzione di Ginevra e ai detenuti, come agli eventuali civili internati, si applicheranno in genere unicamente le regole consuetudinarie e le eventuali norme di diritto interno e di diritto internazionale in materia di diritti umani.
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa tenta nella pratica spesso di dialogare con i diversi gruppi armati ed esso stesso ha più volte denunciato le pessime condizioni di vita nei campi di detenzione, ma quelli che sono i desideri degli attori del diritto internazionale umanitario si scontrano con la peculiare natura di questi conflitti.
I conflitti armati non internazionali, infatti, nascono in genere da scontri ideologici tra diversi gruppi, gruppi che, a differenza degli Stati, non hanno risorse economiche tali da finanziare i campi e gestirli nel rispetto del diritto umanitario e che, sulla base di una forte ideologia politica o religiosa o di una differenza etnica, sono poco propensi nella pratica a “perdonare” al nemico il fatto di essere della fazione opposta.
Questo problema è stato più volte sottolineato dal Comitato della Croce Rossa e da ONG che lavorano sul campo ed è un problema che risulta essere sempre più preoccupante poiché il modello del conflitto armato non internazionale è ormai quello più diffuso, mentre la classica guerra interstatale è stata quasi del tutto abbandonata: nuove misure sono state spesso auspicate ma, come spesso avviene nel contesto dei conflitti armati non internazionali, gli Stati sono oggi più che mai reticenti a creare disposizioni che possano intervenire direttamente sul proprio territorio, limitando la propria sovranità in una questione puramente interna.