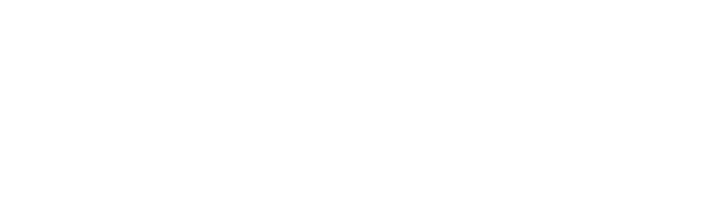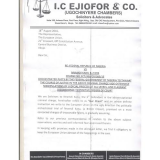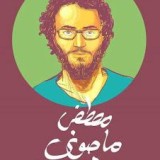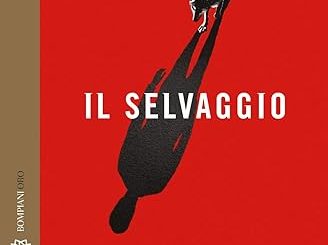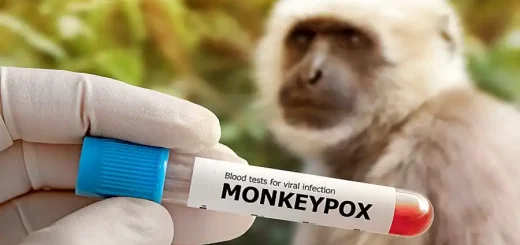Buongiorno buona gente: il negozio del recupero umano e sociale
di Alessandra Montesanto
“Buongiorno buona gente” è il saluto che San Francesco rivolse agli abitanti di Poggio Bustone. A Trieste nasce un negozio che prende il nome proprio da questo saluto, un posto speciale voluto da Valentina Baldacci dopo aver conosciuto una ragazza di Modica (in Sicilia) e Don Ciotti mentre presentava le attività di Libera…
Associazione per i Diritti umani ha rivolto alcune domande a Valentina Baldacci che ringrazia molto per la sua gentilezza e disponibilità.
Parliamo dei prodotti e delle realtà a cui sono legati e della situazione carceraria…
Ciò che ha innescato il processo “inventivo”, ciò che ha generato in me la forza propulsiva che mi ha portata ad aprire questo negozio è stato il volere dar seguito, uno sbocco alle varie iniziative già in corso in varie parti d’Italia, in diversi settori, volte a dare una “seconda possibilità” a delle persone che per ragioni a volte imprevedibili si sono ritrovate in situazioni che le hanno portate a fare delle scelte con conseguenze negative per se stesse e per gli altri. Concretamente, ad esempio: le cooperative che producono dolci grazie alla manodopera dei detenuti devono anche vendere questi prodotti, altrimenti che senso avrebbe impastare ed infornare quintali di biscotti, impacchettarli ed immagazzinarli? Ed oltre che di rivenditori, c’è bisogno anche di qualcuno che informi i potenziali clienti di questo circuito virtuoso. Ecco, ho pensato che di queste ultime due cose avrei potuto occuparmi io.
I miei fornitori mi permettono di offrire prodotti alimentari:
-
coltivati su terreni confiscati alla criminalità organizzata,
-
prodotti nei laboratori delle carceri italiane o da donne che vogliono ricostruire la propria vita dopo aver subito violenze o ingiustizie o da persone disabili,
-
frutto di innovazione e che utilizzano materie prime a basso impatto ambientale.
Alla prima categoria appartengono i prodotti forniti da Libera che è un coordinamento di oltre 1600 associazioni, scuole, gruppi,… impegnate per diffondere la cultura della legalità. La legge sull’uso sociale dei beni confiscati alla mafia, l’educazione alla legalità, l’impegno contro la corruzione, le attività antiusura sono alcuni dei concreti impegni di Libera. I prodotti coltivati su questi terreni sono distribuiti nei punti vendita da Libera Terra. A Trieste da decenni sono acquistabili anche nelle botteghe del commercio equo e solidale.
I detenuti non sempre possono contare sul supporto della famiglia e di amici e quando vengono scarcerati, se non hanno una casa o un lavoro o non riescono ad inserirsi adeguatamente nella società, delinquere sembra essere l’unica scelta possibile.
Grazie ad una legge del 1975, oggi in Italia 1000 detenuti su 60.000 impiegano il loro tempo lavorando per un’impresa e portano avanti ogni giorno progetti in ambiti diversi (artigianato, tessile, manifatturiero). Per capirne l’importanza capitale, basti pensare che le possibilità di tornare a commettere un reato per chi si inserisce in questo circuito, secondo le statistiche, passano dal 75 a meno del 10% con il conseguente risparmio per le casse dello Stato e quindi per ciascun cittadino sui costi che ha la recidiva, e considerare inoltre l’impatto positivo che questa riabilitazione ha anche dal punto di vista psicologico per il detenuto che quindi sarà meno portato ad atti di autolesionismo, avrà maggior fiducia in se stesso, ed una volta scarcerato cadrà più difficilmente in depressione o nelle maglie delle dipendenze da alcol o droga.
Un discorso delicato è anche quello che riguarda le situazioni delle donne che hanno subito violenze e ingiustizie, delle ragazze madri, dei loro figli piccoli e adolescenti. Spesso costoro si trovano sole ed indifese ad affrontare queste problematiche. Ci può essere bisogno di costruire dei percorsi di assistenza, supporto, ospitalità, inserimento lavorativo.
L’associazione Casa don Puglisi, operante in Sicilia, a Modica in provincia di Ragusa, è una delle realtà che garantisce questi servizi. È grazie al lavoro di queste donne, affiancate da esperti del settore, che noi possiamo godere della squisita cioccolata modicana.
Nel mondo che gira attorno a quanto costruito da don Oreste Benzi, troviamo anche l’associazione “La Madre Terra” che dà lavoro ed uno stile di vita dignitoso a persone disabili.
Tutte queste sono realtà importanti perché hanno in comune, tra l’altro, l’essere una seconda possibilità per le donne in difficoltà, per chi sta facendo un percorso di riabilitazione e rieducazione dopo aver commesso degli errori, per “Sora nostra madre terra” (per dirla con San Francesco d’Assisi) dopo essere stata, involontariamente ed inconsapevolmente, uno dei fattori di produzione e fonte di ricchezza per la criminalità organizzata.
Quali sono i vostri fornitori e quali sono i vostri maggiori utenti?
I produttori da cui ci riforniamo sono, tra gli altri:
Al fresco di cantina – carcere di sant’Angelo dei Lombardi
ApuliaKundi – Bari
Associazione Casa don Puglisi – Modica (RG)
Buoni Dentro – IPM Beccaria – Milano
Caffè Lazzarelle, Casa Circondariale di Pozzuoli, Napoli
Campo dei Miracoli, Casa Circondariale di Trani
Carta Manolibera, Casa Circondariale di Forlì
Cooperativa Giovani in Vita – Sinopoli (RC)
Cooperativa Placido Rizzotto – Libera Terra San Giuseppe Jato (PA)
Cotti In Fragranza – IPM Palermo
Dolci Evasioni, Casa Circondariale di Siracusa
Galeorto – Carcere di Trento
I dolci di Giotto – Carcere di Padova
La Madre Terra – Rimini
Pasta 1908 Cooperativa Ippogrifo – Carcere di Sondrio
Sprigioniamo Sapori, Casa Circondariale di Ragusa
Vale la Pena – Rebibbia Roma
La clientela non è omogenea: c’è chi viene perché lavora nel settore della giustizia o coi disabili, chi vuole acquistare cibi biologici, chi è alla ricerca di prodotti senza glutine o senza derivati animali, chi vuole ritrovare i gusti provati durante un viaggio in Sicilia o ha simpatia per don Benzi, chi vuole fare un regalo insolito e sicuramente utile e gradito.
Questo negozio è utile per l’inserimento di categorie fragili nella società: qual è, per lei, il significato del concetto di ETICA, oggi?
Le persone a volte hanno le idee un pochino confuse sull’etica. Le si attribuiscono vari sinonimi, la si scambia con la morale, con la giustizia, con la deontologia. C’è la bioetica, i fondi etici e così via.
Senza perdermi in disquisizioni filosofiche (settore in cui sono totalmente a digiuno), mi limito a considerare che l’etica ci aiuta a capire, secondo il nostro modello morale, se una cosa è buona, giusta, lecita o no. A volte lo usiamo come aggettivo, quindi ritenere un comportamento, un’azione “etica” vuol dire che ci sembra “giusta”, “appropriata”. Secondo me oggi l’etica manca in tantissimi settori. Mi piace immaginarla come un setaccio: in base alla larghezza dei fori (decisa a priori da qualcuno con cognizione di causa) si determina chi passa e chi no, chi risponde ai criteri prefissati e chi invece non è conforme. Nel 2005 l’allora cardinal Ratzinger affermò che eravamo schiavi della dittatura del relativismo. Ecco, mi sembra che la mancanza di etica si possa far rientrare in questa diagnosi.
Per me è etico chiedere alla società (civile e religiosa) di conoscere e farsi carico di chi è fragile (momentaneamente o definitivamente), in sussidiarietà con lo Stato che deve promuovere il benessere e il progresso di tutti i cittadini. Considero etico che ogni lavoratore percepisca la giusta retribuzione (per cui anche le persone disabili o recluse) e che i soldi dei risparmiatori vengano impiegati in maniera “trasparente”. Bene comune, giustizia sociale, etica: concetti – e realtà – da approfondire e perseguire, se vogliamo vivere meglio.
Lei appartiene all’Ordine francescano secolare: ce ne può parlare?
San Francesco d’Assisi visse in un periodo e in una zona di grande fermento civile, economico, religioso (Assisi 1182-1226). Le persone sentivano la necessità di vivere più conformemente al Vangelo, c’era anche molto disappunto nei confronti di sacerdoti e della gerarchia che avevano deviato un po’ dalla fedeltà alla propria vocazione. In questa ricerca di riscoperta delle proprie radici, nacquero però anche alcuni movimenti ereticali, molti si staccarono dalla Chiesa in aperta contestazione. San Francesco invece rimase obbediente alla Chiesa, al Papa, ai vescovi ed ai sacerdoti. Cercando di vivere il vangelo e di amare tutti, attirò molte altre persone: uomini e donne di ogni età, ceto e stato civile, tutti affascinati ed attratti dalla suo modo di porsi. Egli cercò di dare a tutti una regola di vita, sì da poter rendere concreto il vangelo nel loro stato. Così, insieme ad altri ragazzi e uomini diede vita ai “frati minori”; con Santa Chiara ed altre donne fondò l’Ordine delle Sorelle Povere di San Damiano (oggi chiamate “clarisse”); per tutti coloro che avevano già una famiglia o comunque non avevano la vocazione per vivere in povertà, castità e obbedienza, facendo voto davanti a Dio, istituì quello che oggi si chiama Ordine Francescano Secolare (OFS). Quindi i francescani secolari, una volta chiamati “terziari”, vivono il Vangelo sull’esempio di San Francesco ed annunciano Cristo con la propria esistenza e con la parola in famiglia, nelle proprie case, nel lavoro, in parrocchia, nell’impegno sociale, nel volontariato, nelle proprie occupazioni e passatempi. L’eucaristia, i sacramenti, la preghiera alimentano la loro vita. Cercano la persona vivente ed operante di Cristo negli altri fratelli, nella Chiesa, nella Parola di Dio.
Hanno una “seconda famiglia”: la Fraternità, dove, con gli altri fratelli e sorelle, pregano, si formano, si confrontano, crescono umanamente, cristianamente, francescanamente, condividendo la vita, le gioie, le difficoltà, mettendo a disposizione degli altri i doni ricevuti da Dio. I francescani secolari si impegnano anche nelle attività apostoliche, caritative, missionarie in armonia con le indicazioni della Chiesa. L’OFS è ormai diffuso in tutto il mondo e ne fa parte quasi mezzo milione di persone, fra cui anche la sottoscritta.