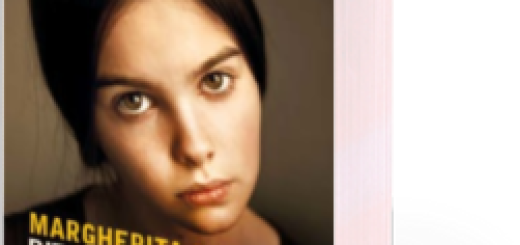Sconfinare. Viaggio alla ricerca dell’altro e dell’altrove
di Alessandra Montesanto
E’ uscito da pochi giorni il saggio intitolato Sconfinare. Viaggio alla ricerca dell’altro e dell’altrove a cura di Donatella Ferrario, per San Paolo Edizioni.
«Questa è la storia di un viaggio. Come tutti i viaggi è nato da un’idea: la voglia di esplorare un luogo in cui si è stati e in cui ci si trova ogni giorno, in cui pare di muoversi a proprio agio, di conoscerne strade e scorciatoie. Un luogo tanto comune a tutti da divenire insignificante, in senso etimologico. Il confine».
Associazione per i Diritti umani ha intervistato Donatella Ferrario – giornalista, lavora per Milano Multietnica – e la ringrazia per la sua disponibilità.
“Insignificante”, in senso etimologico, significa “privo di significato”: quali sono, invece, i luoghi che comunicano ancora qualcosa?
Ogni luogo comunica sempre qualcosa, a patto di porsi in un atteggiamento di apertura, in una disposizione a vedere e ascoltare. Luoghi fisici ma anche luoghi dell’anima, ricordi di ciò che magari non esiste più, se non dentro di noi o in una memoria condivisa o storica.
Sconfinare è un viaggio che fa parte dell’esperienza di ognuno. Ho riflettuto, insieme ad altri compagni di avventura – da Abraham Yehoshua a Paolo Rumiz, da Claudio Magris ad Antonia Arslan, Eugenio Borgna, Uliano Lucas, Pap Khouma, José Tolentino Mendonça, Furio Colombo e Nello Scavo – su un luogo che, spesso, è un non luogo, inafferrabile, talora imposto da trattati, segnato da cippi, da dogane, tracciato sulle mappe: il confine, appunto. E ho pensato poi di allargare l’orizzonte: perché, anche se non ce ne rendiamo conto, noi, come esseri umani, siamo sempre portati ad andare oltre, a scavalcare i muri e/o a guardare cosa c’è al di là. È l’atteggiamento del bambino, quell’istinto che abbiamo – magari sepolto dagli anni e dall’abitudine – e che dovremmo recuperare: quello di andare a vedere, di renderci conto. Il libro, attraverso più voci e sguardi, ritrova una convinzione comune a tutti: il fatto che, in ogni nostro atto, sconfiniamo, andiamo oltre. Poi magari ritorniamo, ma il movimento è sempre presente in noi: è un andare e venire. E al ritorno siamo molto diversi da come siamo partiti. Basta pensare all’esperienza che tutti hanno fatto di un viaggio, non importa quanto lontano.
Quindi ogni luogo è significante: anche il più consueto, il più routinario. E prende significato dalle persone che lo abitano e lo attraversano.
Anche la nostra pelle è un confine, quello della nostra identità: pelle chiara, scura, tatuata… Come è stato trattato, nel libro, il tema della ricerca di un’identità?
La domanda, più o meno sottintesa, è stata: cos’è l’identità? Cosa caratterizza me, te, un altro? Un confine, un muro invalicabile, può proteggere questa identità, questo essere appartenenti a un qualcosa (un popolo, una nazione, una tradizione, una lingua, ecc. ecc.)? Ognuno ha risposto secondo la sua visione esistenziale. Di fatto l’identità, il nascere in un luogo, da certi genitori, il vissuto, è sempre un qualcosa in movimento. La mia unicità di individuo non viene messa in crisi dal contatto con l’altro, la mia nascita non mi definisce per sempre. È come un’impronta che muta, rimanendo però la mia impronta. Non si può parlare di identità senza aver presente la riflessione di Amartya Sen («dobbiamo avere piena consapevolezza di possedere molte e distinte affiliazioni, e di poter agire con ognuna di esse in molti e diversi modi»), che supera il determinismo e apre a decine di possibilità.
Nelle conversazioni di Sconfinare spesso fa capolino la nostra identità europea, penso a Paolo Rumiz e a Pap Khouma, per esempio. Quel riconoscimento che non sempre ci è chiaro di un’appartenenza, oggi così bistrattata che ha, come dice Rumiz, un bisogno disperato di cantori.
Un ulteriore argomento importante è quello del razzismo: fino a poco tempo fa era strisciante, ora sempre più evidente. Quali sono, a suo parere, i motivi che stanno riportando a galla nella nostra società slogan e comportamenti sempre più violenti nei confronti, ad esempio, degli stranieri?
Si fa leva sulla paura. Quella irrazionale, inconscia: la paura del diverso da me, di colui/colei che possono minare la mia identità – per riandare al tema della domanda precedente – sottrarmi quello che è mio, rubarmi il lavoro, ottenere benefici a mio discapito.
La paura genera, come il sonno della ragione, dei mostri. Chi detiene il potere (ogni forma di potere, peraltro) questo lo sa benissimo e in questo momento storico il potere lo si usa in modo spregiudicato: le tematiche sono poche, depauperate di verità, ma su queste si insiste quotidianamente, si parla di invasione di migranti, di pericolo, si sottolineano solo certi episodi e se ne tacciono altri. E non importa se i numeri e le percentuali negano, per esempio, l’invasione: il seme della paura fa in fretta ad attecchire. Un proclama ripetuto più volte finisce per essere una verità, qualcosa di indiscusso.
Si è completamente perso il senso del limite, il confine, se si vuole, tra ciò che è lecito dire e cosa no: l’amplificazione talora irresponsabile dei media o dei social fa poi da cassa di risonanza. Il linguaggio pare funzionare di più se è urlato, se usa parole che incitano all’odio, che risvegliano paure ataviche. Dobbiamo fare i conti con i nostri fantasmi, prendere coscienza che l’altro da noi non è un depauperamento ma è una fonte di ricchezza. Riandare alla storia: che dovrebbe essere un cartello indicatore per non ripetere gli stessi errori, o che dovrebbe ricordarci che, da sempre, l’umanità migra e che anche noi siamo stati un popolo di migranti. Il razzista per lo più lo è insieme ad altri: si sente rafforzato, legittimato, protetto da chi pare pensarla come lui. Il gruppo è il deterrente della sua paura.
La risposta è nella solidarietà, nel rispondere punto per punto: mi viene in mente Paolo Rumiz quando afferma che ciò che fa davvero paura è il silenzio impaurito di chi si professa antirazzista ma tace. Ma per andare oltre e combattere i razzismi ci vuole una coraggiosa autocritica: uno dei grandi errori degli scorsi anni, come racconta sempre Rumiz nel libro, è stato di aver trascurato e abbandonato a se stesse le periferie.
Qual è il luogo che una persona può considerare “casa”?
Ognuno ha una sua personale risposta. Direi che casa è il luogo in cui sento che ci sono o possono esserci le condizioni perché come individuo riesca a esprimermi in tutte le mie potenzialità. In sostanza casa è per me libertà: di crescere, di poter manifestare la mia opinione. Va oltre il senso di appartenenza: casa è proprio senza confini. È l’illusione di avere infinite possibilità. Per Pap Khouma casa è il luogo in cui puoi entrare e chiudere la porta: dice “sono io che faccio entrare e faccio uscire il mondo”.
Quanto è importante riuscire a “sconfinare” da se stessi per entrare in contatto con l’altro? E scoprire, poi, che non c’è un vero e proprio limite…
Il libro si è proposto di mostrare che lo sconfinamento è la cifra quotidiana del nostro vivere. Anche se non ce ne accorgiamo, come dicevo. Si è parlato anche di confini che devono esistere: quelli morali o i limiti imposti dalle leggi. Ma ciò che è elettrizzante è proprio accorgersi che la “contaminazione” con l’altro avviene sempre, anche a nostra insaputa, e che non ci può fare male, anzi, ci arricchisce, ci fornisce degli occhiali che ci fanno guardare più in là, ci offre la possibilità di osservare il mondo da diverse prospettive. Oltretutto il rapporto è sempre circolare, si dà e si riceve. E la contaminazione inizia ogni giorno, non appena apriamo gli occhi e ci guardiamo intorno.